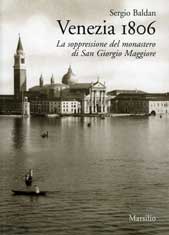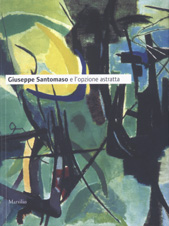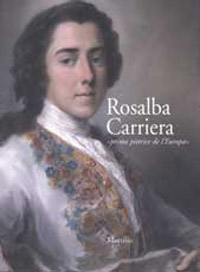La serie dei volumi sui grandi generi della letteratura italiana si conclude con questo, dedicato alla lirica; ultimo, ma idealmente primo, perchè la lirica è davvero il genere principe della nostra tradizione: in primo luogo cronologicamente, perchè lirici sono i testi letterari più antichi (fino a importanti scoperte che negli ultimi anni hanno movimentato un campo nel quale sembrava che non ci fosse altro da raccogliere); poi per l’altezza cui ben presto giunse il genere, quando Petrarca lo riavviò su basi nuove, proseguendo e insieme superando il grande inizio dei trovatori provenzali; in terzo luogo, per la sua durata: solo nella letteratura italiana è possibile che un autore dell’Ottocento ripeta molte parole di un lirico di cinque secoli prima, appunto il Petrarca; per non dire della presenza di Dante nel Novecento lirico, per esempio in Montale. E’ una condizione unica nel quadro delle altre letterature europee, romanze e germaniche, nelle quali di una tradizione attiva fino ai tempi moderni – o fino alla soglia dei tempi (post?) moderni – non si può parlare prima del XVI o piuttosto del XVII secolo. Una simile situazione, così intrinsecamente connessa alla nobile dignità intellettuale dell’italiano, dipende dalle vicende della lingua e della cultura, dall’essere stato il Petrarca promosso a modello durante il Rinascimento, con effetti durevoli anche su autori che, come Leopardi, non possono certo dirsi petrarchisti. In tal modo la lirica italiana ha dato vita a un discorso eletto, aristocratico; ma di un’aristocrazia formata, come dicevano i poeti del Dolce stil nuovo, da chi è gentile di cuore, da chi è capace di intelligenza e di affetti.
INDICE
Premessa
di Francesco Bruni
“Vaghe stelle dell’orsa…”
La più antica testimonianza di poesia lirica italiana
di Alfredo Stussi
Allocuzione e apostrofe nella poesia delle origini
di Giorgio Colussi
Avere e non avere: dai trovatori a Petrarca
di Roberto Antonelli
Lingua e testi della scuola poetica siciliana
di Rosario Coluccia
“Oltre la spera che più larga gira”: esempi di realismo rapsodico nella Vita nuova
di Marco Santagata
Battaglia di pensieri e nuovi amori nel dopo-Berenice: “Voi che ‘ntendendo” tra Vita nuova e Convivio
di Aldo M. Costantini
Petrarca e l’invenzione del “Canzoniere”
di Stefano Carrai
Petrarca, la lirica, la musica
di Guido Capovilla
Boiardo innamorato, o il “vivere forte” di un amante
di Tiziano Zanato
Fra petrarchismo e Barocco. Le Rime di Torquato Tasso
di Arnaldo Di Benedetto
Le seduzioni barocche della “Sirena marina”
di Andrea Battistini
Dare del tu all’universo
di Manlio Pastore Stocchi
Il canto della donna al telaio e il dialogo con l’assente: A Silvia di Leopardi
di Francesco Bruni
L’interlocutore ideale. Fine dell’errore di Niccolò Tommaseo
di Fabio Danelon
La Creazzione der Monno e i primi sonetti biblici di Belli
di Pietro Gibellini
Montale tra Leopardi e Schopenhauer. Lettura di Spesso il male di vivere ho incontrato…
di Luigi Blasucci
Il dialogo con le ombre. Note sulla poesia di Giorgio Caproni
di Silvana Tamiozzo Goldmann
La linea metafisica nella poesia italiana del Novecento: esiti di fine Millennio
di Maria Antonietta Grignani
Appendice
Scrittori contemporanei. Incontro con Patrizia Valduga
a cura di Silvana Tamiozzo Goldmann
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it