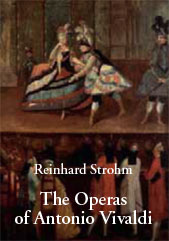L’idea
di dedicare a Lionello Lanciotti il primo volume di «Orientalia
Venetiana» è nata tra i docenti del Seminario di Letteratura Cinese
dell’Università di Venezia alcuni anni fa. Egli aveva appena lasciato
l’Istituto, di cui era stato direttore per tredici anni, per recarsi a
prestare la sua opera in un’altra Università, e i suoi ex-
collaboratori intendevano dimostrargli la loro riconoscenza per
l’impegno e l’abnegazione con cui aveva adempiuto al suo ufficio. Ora
il volume viene finalmente dato alle stampe, e si può affermare a
ragione che esso è qualcosa di più che un omaggio a Lionello Lanciotti:
esso è anche, in una certa misura, un’espressione concreta del suo
successo nel ruolo di docente e di Maestro; è, paradossalmente, in gran
parte opera sua. Dei quattordici contributi che compongono il volume
almeno nove sono stati scritti da suoi discepoli, da studiosi che si
sono formati direttamente alla sua scuola e che hanno tratto dal suo
magistero e dal suo esempio un’immagine chiara e netta della severità
dello studio e della ricerca
INDICE
Presentazione
Magda Abbiati, A proposito dei classificatori nominali in cinese moderno
Paolo Beonio-Brocchieri, Considerazioni sul periodo assiale: da Pitagora a Mo Tzu
Adriana Boscaro, I Gesuiti e gli inizi della stampa cristiana in Asia Orientale
Alfredo Cadonna, ‘Astronauti’ taoisti da Chang’an alla luna
(Note sul ms. di Dunhuang S 6836 alla luce di alcuni lavori di E. H, Schafer)
Patrizia Dadò, La riabilitazione di Liu Shaoqi
Herbert Franke, Tan-pa, a Tibetan Lama at the Court of the Great Khans
Federico Greselin, Brevi note sul dibattito intorno alla nazionalizzazione della pittura ad olio
A. F. P. Hulsewé, Some remarks on statute labour during tbe Ch’in and Han period
Cristina Pisciotta, Lettura critica di una commedia di Lao She
Mario Sabattini, Il Paleolitico in Cina
Guido Samarani, Tendenze storiografiche e lotta politica nell’ultimo decennio in Cina: l’esempio della storia degli Stati Uniti d’America
Maurizio Scarpari, Determinazione e nominalizzazione in cinese classico
Giovanni Stary, Nurhaci e il suo regno tribale alla fine del XVI secolo
Tsien Tche-Hao, Le juridisme du droit chinois archaique dans le Shujing et le Zhouli
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it