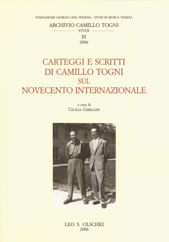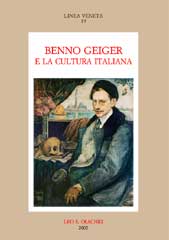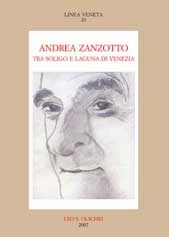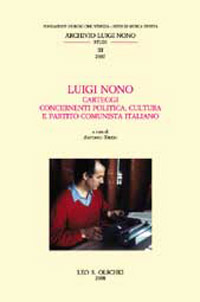Già
nella presentazione del primo volume di lettere e scritti di Camillo
Togni principalmente attribuibili al Novecento musicale italiano, edito
in questa Collana, si era identificata nel Musicista quella «persona
estremamente ordinata su ogni piano dell’esistenza (intellettuale,
manuale, eccezionale, quotidiana)» consapevolmente dedita a preservare
dal degrado ogni documento di vita. La particolare cura dedicata dal
Maestro a conservare lettere, telegrammi, minute e copialettere,
testimonianze finanche minime di tutti i rapporti culturali e
intersoggettivi intrapresi nell’arco di un cinquantennio, aveva
permesso una ricognizione puntuale di un gran numero di scambi e di
contatti con i più disparati contesti musicali italiani del Novecento.
La
stessa indagine riprende qui assumendo ora i documenti più
significativi, ancora lettere, lettere ricevute, lettere spedite,
scritti, approfondimenti, semplici appunti, memorie riguardanti l’ampio
mondo, tedesco ovvero internazionale, della Musica del Novecento. A
partire dal contatto pervicacemente cercato, con commossa apprensione,
con il massimo modello della creatività di Togni, dalla giovinezza alla
maturità: Arnold Schoenberg.
INDICE
Parte Prima – Carteggi
Parte Seconda – Altri Scritti
Appendice
Giada Viviani – Camillo Togni studia le Variationen für orchester op. 31 di Schoenberg
Indice dei nomi
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it