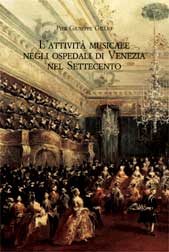Il volume accoglie una selezione delle relazioni
più significative presentate nel corso di un Convegno Internazionale
organizzato alcuni anni fa dall’Istituto “Venezia e
l’Oriente” e dalla European Society for Central Asian
Studies. I profondi mutamenti geopolitici e geoeconomici che hanno
interessato e continuano ad interessare quell’area del mondo
e la sua identità culturale, hanno richiesto aggiornamenti
significativi dei singoli contributi, nonché l’integrazione
con alcuni nuovi studi che hanno arricchito le tre sezioni tematiche
dell’opera (“Space and Time in Central Asia History”,
“Redrawing the Lines of Identity”, “Reforms and Representations
of Legitimacy”).
TABLE OF CONTENTS
Foreword
Inaugural address, Giampiero Bellingeri, Rog, Urok,
Orak, Orakul
I. SPACE AND TIME IN CENTRAL ASIAN HISTORY
Saidakbar Saidovich Agzamkhodjaev, Reforming Movement in Central Asia in the beginning of XX Century: New Interpretation and Reevaluation
Jiri Becka, Scholars from Khurasan in Czech Mediaeval Science
Hansje Braam – Marc Vandamme, Systematic Name Management in
Digital Central Asian Textual Resources
Suchandana Chatterje, The Rehabilitation of Heroes in Central
Asia
Paul Geiss, Tribal Commitment and Political Order in Central
Asia. A Reconsideration
Manfred Lorenz, Zur weiteren Entwicklung der tagikischen Sprache
Lars-Erik Nyman, An Oral Re-evaluation of the 20 Century Tibetan
History
Giovanni Pedrini, Nomadik Feudalism of the Steppes
Jadwiga Pstrusinska, Eurasiatic Context of the Old Celtic Cultural
Phenomena: the Case of Torque
Gianroberto Scarcia, Zoroastrian Calendar and its Myth. An
Abstract
Dov Yaroshevski, Contest over the Waqf in the Khorezm Republic,
1920-24
II.REDRAWING THE LINES OF IDENTITY
Mustafa Aydin, Identities in Transition. Nationality, Religion
and Regional Security in Former Soviet Central Asia
Giampaolo R. Capisani, Au sud de la Russie: quelques considérations
géo-economiques à propos des Pays d’Asie Centrale
et du Caucase
M. Cristina Cesaro, Walking a Tightrope: a Quest for Uyghur
Identity
Boris-Mathieu Petric, Renaissance de la communauté de
voisinage dans la ville de Tachkent: retour à la tradition
ou expressíon d’un nouvel imaginaire social?
III. REFORMS AND REPRESENTATIONS OF LEGITIMACY
Rahimjon H. Alimov, Economic Transformation Efficiency in Uzbekistan
Elena Boikova, Modern Political Elites in the Central Asian
States
Guido M. R. Franzinetti, Economic Reform in Uzbekistan and
Central Asia: some Hypotheses
Lilia Moshina, The Policy of Land Reform and Privatization
in Agriculture of Uzbekistan
Sevar Nurmukhamedova, Some Aspects of Economical Reform in
Independent Uzbekistan
Abdulkhalil A. Razzakov, Privatization in Uzbekistan: its Basic
Stages
Riccardo Redaelli, Between Pervasive Tribal Structures and
Alien Patterns of Polity: Afghanistan and the Taliban
Rustem Zhangozha, Newly Independent States in Central Asia
– within the First Decade of Their Independence
Authors
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it