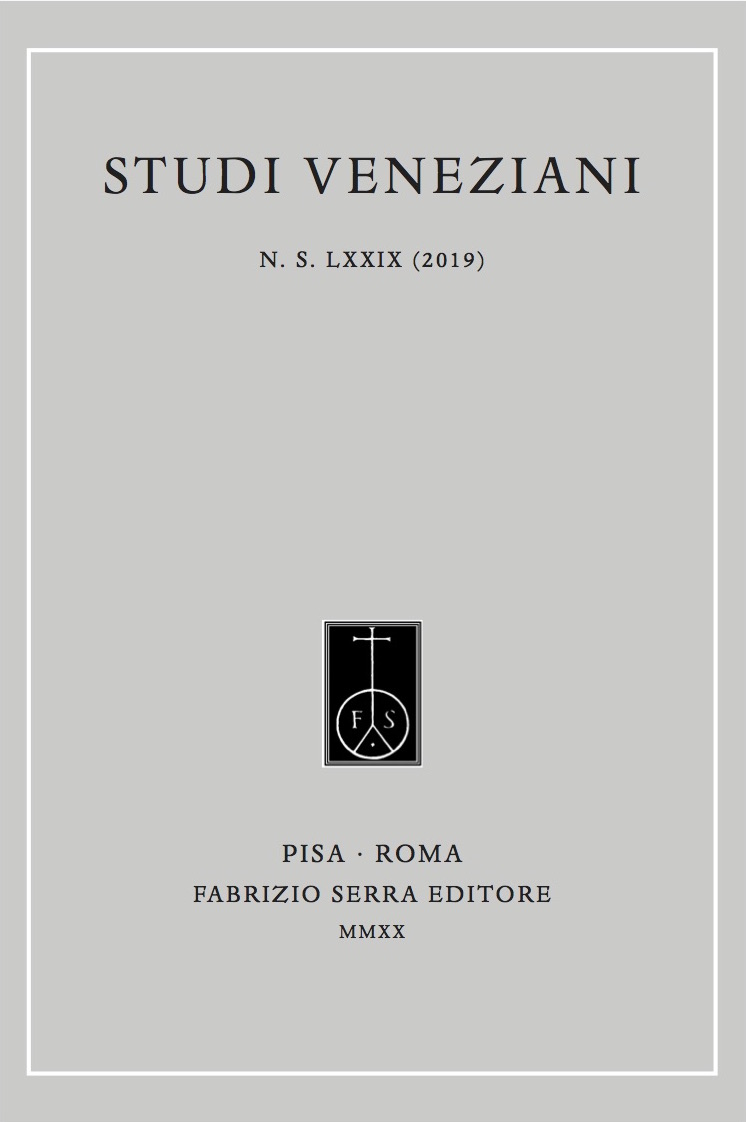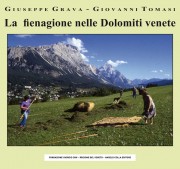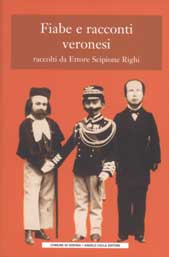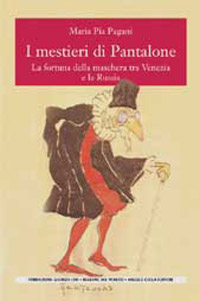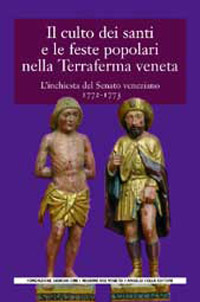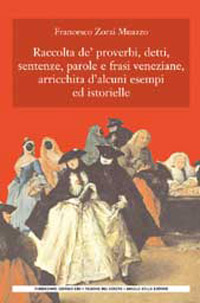Con il termine “scuola” si è soliti indicare qualsiasi associazione di
cittadini organizzata con finalità devozionali e assistenziali e
amministrata da laici sotto il vigile controllo delle magistrature
veneziane che ne consentivano l’istituzione, ne approvavano gli statuti
(mariegole), controllavano l’operato del gastaldo e degli altri
dirigenti (“banca”) e, in caso di abusi, ne decretavano la
soppressione. Delle cosiddette “scuole grandi”, da sempre note e
studiate perche disponevano di grandi capitali, sedi sontuose, sfarzosi
apparati per le manifestazioni cittadine – ma che nel Cinquecento si
contavano sulle dita di una mano – si sa molto; quasi nulla invece si
conosce delle centinaia di “scuole piccole” sulle quali fino ad oggi
mancava qualsiasi elemento concreto per avviare studi seri. Ci sono
voluti trent’anni di ricerche d’archivio all’autore di questo libro per
raccogliere i documenti relativi agli statuti di 925 confraternite
veneziane minori di varia natura – tante sono quelle censite nel volume
che coprono un arco temporale amplissimo: dal secolo XIV alla caduta
della Repubblica. I dati presentati dall’autore in ordine cronologico
scuola per scuola sono quelli relativi agli eventi che hanno
caratterizzato la vita di questi sodalizi – detti anche scuole d’arte,
suffragi, sovvegni, fraterne e confraternite – in cui, a seconda della
professione o mestiere svolto, tutti i cittadini veneziani, maschi e
femmine che avessero compiuti i 15 anni di età, si potevano associare
liberamente per godere di aiuti, garanzie, vantaggi spirituali e
materiali. Gli iscritti a una scuola potevano contare su pratiche di
assistenza, accompagnamento funebre e suffragio in caso di malattia
mortale; di medicine e di sussidio quotidiano in caso di momentanea
inabilità al lavoro (purche non causata da ferimenti dovuti a risse o
spericolatezze, o al “morbo gallico”). Nei periodi di pestilenza,
inoltre, i sovvegni assicuravano un’assistenza pecuniaria anche a chi
fosse stato obbligato a rimanere sequestrato in casa. E all’assistenza
a intere famiglie precipitate nella più grave indigenza per repentini
tracolli economici, dovuti per esempio a naufragi o a incendi, e
costrette all’elemosina, provvedeva la “Fraterna dei poveri
vergognosi”. Ma erano previsti anche aiuti per ragazze bisognose, a
favore delle quali erano sorteggiate regolarmente “grazie” da dieci
ducati perche potessero sposarsi o monacarsl. E infine, alle casse
delle scuole piccole, soprattutto nel loro momento migliore (in età
rinascimentale e nel Seicento) attingeva spesso anche la Serenissima
Repubblica per far fronte alle spese di armamento della flotta e alle
guerre contro i Turchi. La decadenza sopraggiunse nel Settecento, in
seguito alla proliferazione delle scuole abusive, e soprattutto delle
“compagnie dei morti”. Queste, associando un grande numero di iscritti
(fino a 45.000, veneziani e non, nel 1784), con il pretesto del
suffragio ai defunti e della estrazione annuale di un certo numero di
“grazie” da 100 lire l’una, organizzavano delle vere e proprie
lotterie, nel corso delle quali talvolta scoppiavano disordini e
tafferugli. Ne seguÌ dapprima la soppressione delle compagnie dei morti
da parte del Consiglio di Dieci, e poi, alla caduta della Repubblica,
la soppressione napoleonica di tutte le scuole. L’interessante rassegna
di documenti recuperati e presentati qui con intelligente chiarezza è
corredata da un utile glossario di termini, non tutti reperibili nei
dizionari del dialetto veneziano, e da un indice dei nomi che risulterà
necessario anche ai cultori di altre materie avendo l’autore prestato
particolare attenzione, nel corso dell’opera, all’attività di pittori,
scultori, architetti e musi ci a favore delle scuole.
INDICE
Presentazione, di Antonio Niero
Note d’archivio per la storia delle confraternite veneziane,
di Gastone Vio
Sigle e abbreviazioni delle fonti
SESTIERE DI CASTELLO
– Parrocchia di san Pietro di Castello [1]
– Parrocchia di san Biagio [2]
– Parrocchia di san Martino [3]
– Parrocchia di san Giovanni Battista in Bràgora [4]
– Parrocchia di sant’Antonin [5]
– Parrocchia di santa Ternita [6]
– Parrocchia di san Severo [7]
– Parrocchia di santa Maria Formosa [8]
– Parrocchia di santa Marina [9]
– Parrocchia di san Lio [10]
– Parrocchia di santa Giustina [11]
– Parrocchia di San Giovanni in Oleo, detto san Giovanni Novo
[12]
– Parrocchia di san Provolo [13]
SESTIERE DI SAN MARCO
– Parrocchia di san Marco [14]
– Parrocchia di san Geminiano [15]
– Parrocchia di san Moisè [16]
– Parrocchia di santa Maria Zobenigo [17]
– Parrocchia di san Maurizio [18]
– Parrocchia di san Vìdal [19]
– Parrocchia di san Samuele [20]
– Parrocchia di sant’Angelo [21]
– Parrocchia di san Benetto [22]
– Parrocchia di san Paternian [23]
– Parrocchia di san Luca [24]
– Parrocchia di san F antin [25]
– Parrocchia di san Salvador [26]
– Parrocchia di san Bartolomeo [27]
– Parrocchia di san Giuliano [28]
– Parrocchia di san Basso [29]
SESTIERE DI CANNAREGIO
– Parrocchia di santa Lucia [30]
– Parrocchia di san Geremia [31]
– Parrocchia di san Marcuola [32]
– Parrocchia di san Leonardo [33]
– Parrocchia di santa Maria Maddalena [34]
– Parrocchia di santa Fosca [35]
– Parrocchia di san Marziale [36]
– Parrocchia di san Felice [37]
– Parrocchia di santa Sofia [38]
– Parrocchia dei santi Apostoli [39]
– Parrocchia di san Canciano [40]
– Parrocchia di santa Maria Nova [41]
– Parrocchia di san Giovanni Crisostomo [42]
SESTIERE DI SAN POLO
– Parrocchia di san Polo [43]
– Parrocchia di san Tomà [44]
– Parrocchia di san Stin (santo Stefano prete) [45]
– Parrocchia di sant’Agostin [46]
– Parrocchia di san Boldo (sant’Ubaldo) [47]
– Parrocchia di sant’Aponal (sant’Apollinare) [48]
– Parrocchia di san Silvestro [49]
– Parrocchia di san Mattio [50]
– Parrocchia di san Giovanni Elemosinario [51]
SESTIERE DI SANTA CROCE
– Parrocchia di Santa Croce [52]
– Parrocchia di san Simeone Profeta (san Simon Grande) [53]
– Parrocchia dei santi apostoli Simone e Giuda (san Simon Piccolo)
[54]
– Parrocchia di san Giovanni Decollato [55]
– Parrocchia di san Giacomo dall’Orio [56]
– Parrocchia di san Stae (sant’Eustachio) [57]
– Parrocchia di santa Maria Mater Domini [58]
– Parrocchia di san Cassiano [59]
SESTIERE DI DORSODURO
– Parrocchia di san Nicolò dei Mendicoli [60]
– Parrocchia dell’angelo Raffaele [61]
– Parrocchia di san Basilio [62]
– Parrocchia di santa Margherita [63]
– Parrocchia di san Pantalon [64]
– Parrocchia di san Barnaba [65]
– Parrocchia di san Trovaso (santi Gervasio e Protasio) [66]
– Parrocchia di sant’Agnese [67]
– Parrocchia di san Vìo (santi Vìto e Modesto) [68]
– Parrocchia di san Gregorio [69]
– Parrocchia di santa Eufemia della Giudecca [70]
Glossario
Indice dei nomi
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it