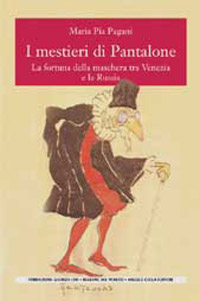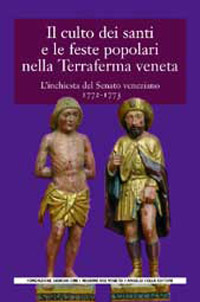Il presente lavoro sulla vita musicale nelle chiese veneziane è il primo risultato di uno studio tuttora in corso sulle modalità della produzione, della circolazione e del consumo della musica sacra da chiesa a Venezia e nel Veneto fino al primo Seicento. Muovendo dall’indagine sulle istituzioni potenzialmente promotrici di esecuzioni musicali e sui sistemi di finanziamento da esse adottati, si intende giungere ad affrontare alcune delle problematiche inerenti il repertorio musicale: i suoi canali di diffusione, le sue destinazioni e i suoi utilizzi nonché la stessa realizzazione sonora del testo musicale negli ambienti considerati. Per l’attuazione di un simile progetto è stato necessario sperimentare un metodo di ricerca che si discosta per molti aspetti da quello comunemente adottato negli ‘studi documentari’ sulla storia della musica: si è scelto infatti di non porre limitazioni precise riguardo all’ambito cronologico né circoscrivere l’indagine ad un numero predefinito di istituzioni, ma di avviare invece una ricerca ‘trasversale’ e comparativa per determinare quale fosse il contributo fornito dal complesso delle istituzioni alla vita musicale cittadina.
INDICE
Elenco delle abbreviazioni
Prefazione
I. Le Istituzioni Ecclesiastiche a Venezia nel Cinquecento
Una mappa
Venezia, la Chiesa e le chiese veneziane
II. Le Decime Ecclesiastiche
La storia di una tassa
I fascicoli cinquecenteschi di «condizioni»
III. La musica nelle chiese veneziane secondo i fascicoli di “condizioni”:un quadro di riferimento
Gli organisti
Altri salariati
Interventi occasionali di musicisti
Un quadro di riferimento
IV. Il Finanziamento della musica nelle chiese veneziane
Chiese parrochiali
Monasteri
La cappella musicale del convento dei Santi
Giovanni e Paolo: un caso esemplare?
La cappella musicale del convento di Santo Stefano
Le feste principali dell’anno liturgico e il periodo quaresimale
Le «compiete musicali»
Le messe novelle e la «sagra» delle novizie
V.Le scuole piccole
Una presenza significativa
Struttura e organizzazione
Il finanziamento delle cerimonie solenni e la gestione dei fondi comuni
Istituzioni a confronto: le scuole grandi
VI. Feste, musica e musicisti : continuità nella tradizione
Il ruolo della musica nello svolgimento della festa
L’utilizzo degli strumenti nelle musiche delle celebrazioni solenni: una tradizione antica
Il ruolo dei cantori
Il ruolo degli strumenti: alcuni indizi
La musica nella legislazione ecclesiastica locale
Compagnie di cantori e compagnie di strumentisti
Conclusioni
Appendice
Bibliografia citata
Indice dei nomi e delle cose notevoli
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it