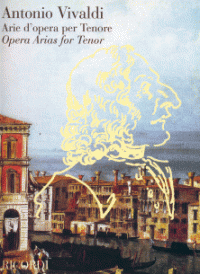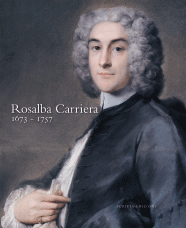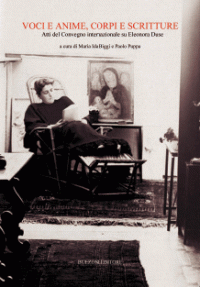Nel pieno della rinascita operistica vivaldiana, mentre in tutto il mondo teatri d’opera, direttori d’orchestra e case discograï¬che vanno avidamente in traccia della musica teatrale di Vivaldi, ecco un’edizione che colma un’esigenza sempre più sentita: disporre di un repertorio di arie scelte che rappresenti uno spaccato della grandissima produzione vivaldiana e che sia al contempo un banco di prova per i cantanti che intendono accostarvisi. Grandi assenti del mercato editoriale, le arie d’opera di Vivaldi non erano ï¬no ad oggi singolarmente disponibili se non per mezzo di vecchie edizioni o di volenterose trascrizioni dai manoscritti. Presentare al pubblico queste due raccolte, composte da 12 arie ciascuna ridotte per canto e pianoforte, signiï¬ca mettere a disposizione di un largo pubblico – ben oltre la cerchia degli studiosi e delle grandi produzioni teatrali – un rappresentativo repertorio di teatro vivaldiano utile a cantanti professionisti, dilettanti, insegnanti, studenti. Lo scopo didattico-divulgativo è forse il più evidente di questa pubblicazione: poter far studiare e formare una vocalità barocca su esempi di grande utilità tecnica; permettere a un numero sempre maggiore di cantanti di poter conoscere e approfondire il repertorio barocco; aprire nuove, larghe possibilità per audizioni e concerti. L’evidente valore pratico delle due raccolte non pone in secondo piano l’afï¬ dabilità scientiï¬ca del lavoro, condotto sulle edizioni critiche dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi e corredato da un’esauriente introduzione critica di Federico Maria Sardelli in cui si delineano gli elementi essenziali del mondo teatrale vivaldiano.
12 Arie d’opera per Tenore – 12 Arie d’opera per Baritono/Basso