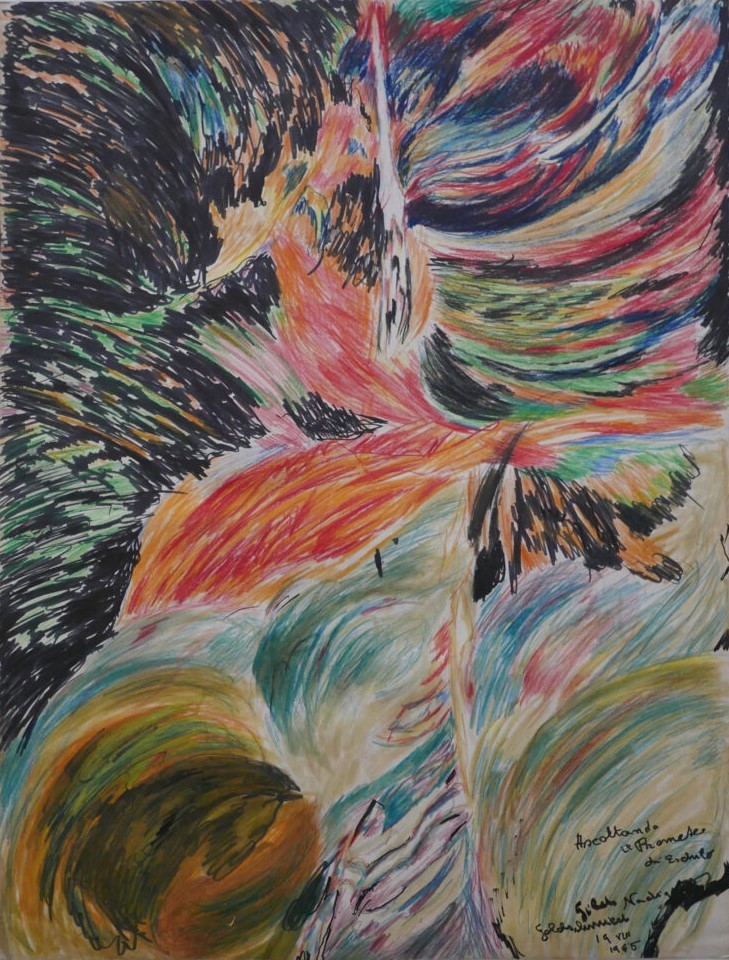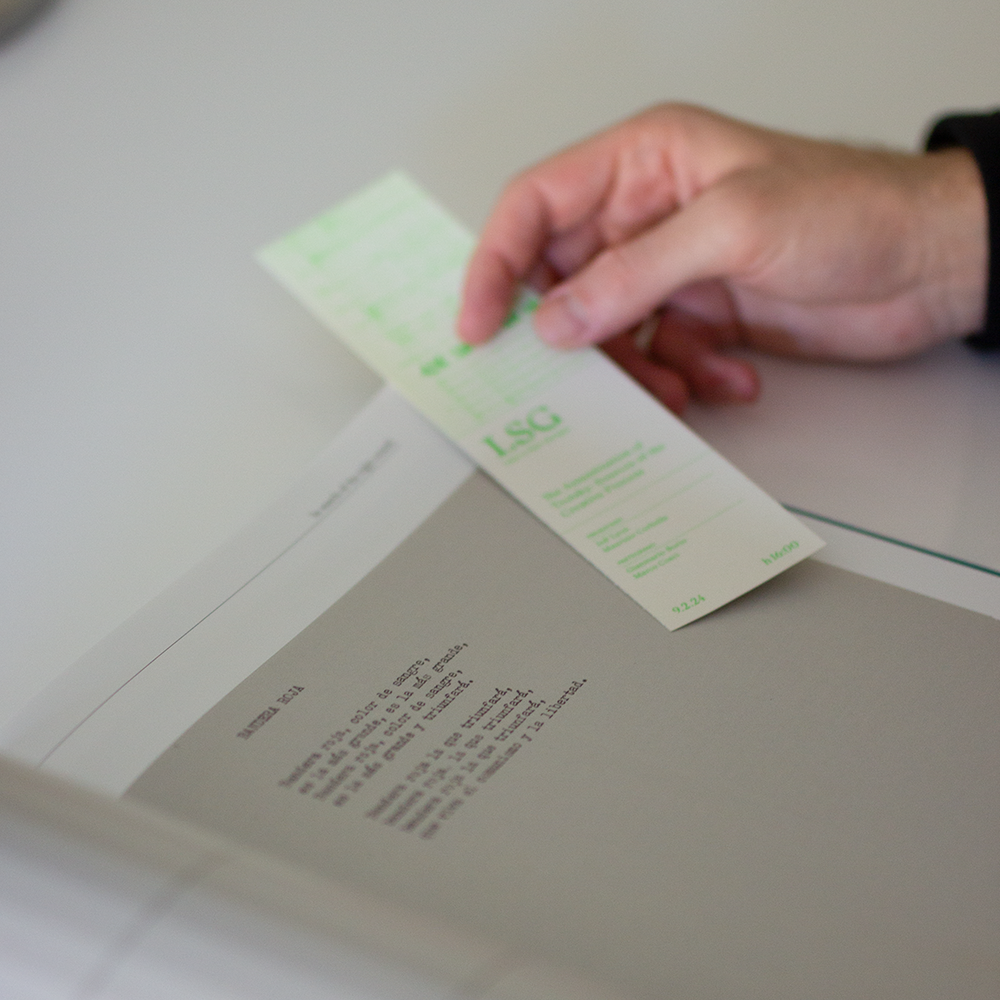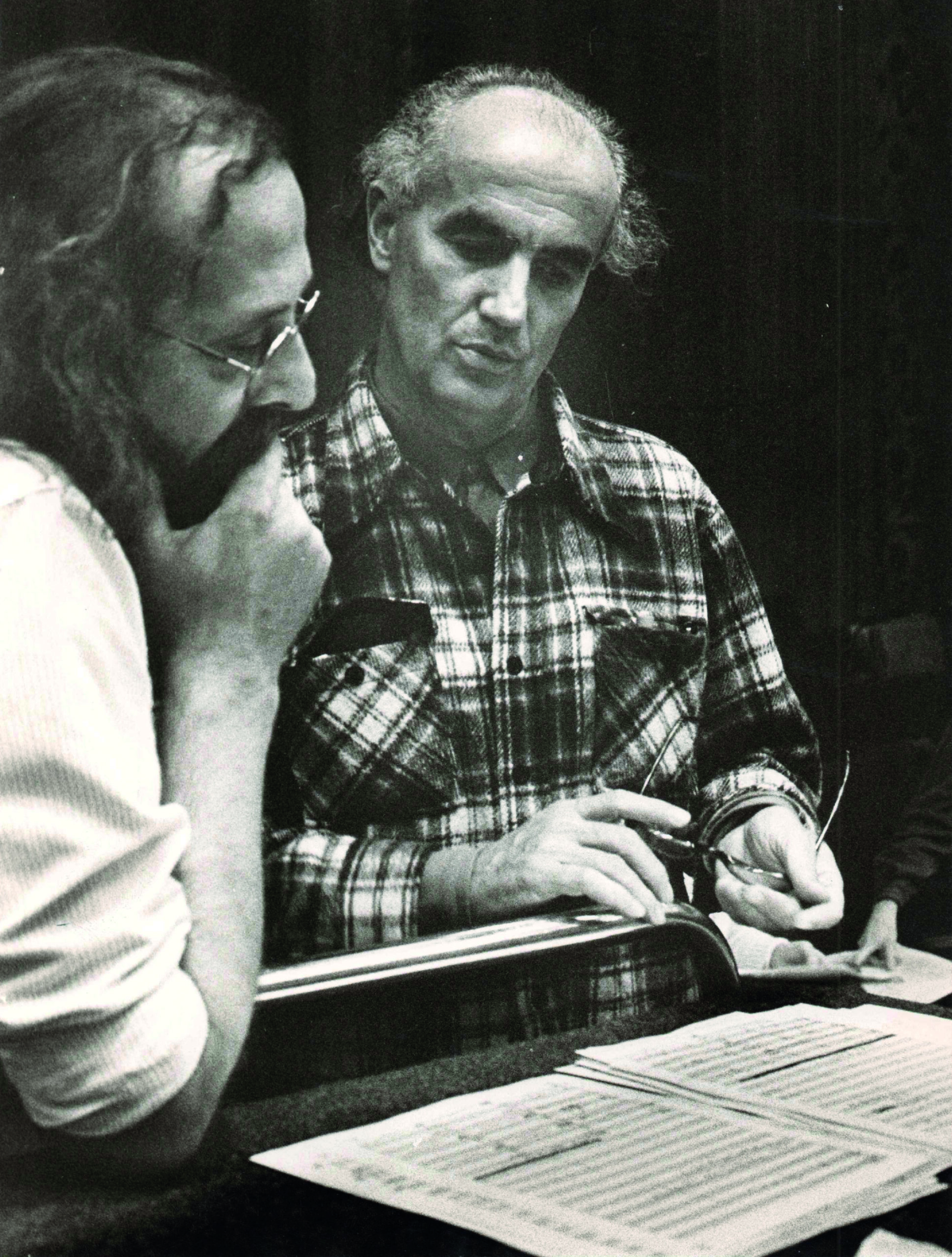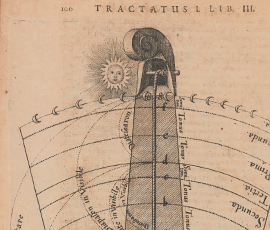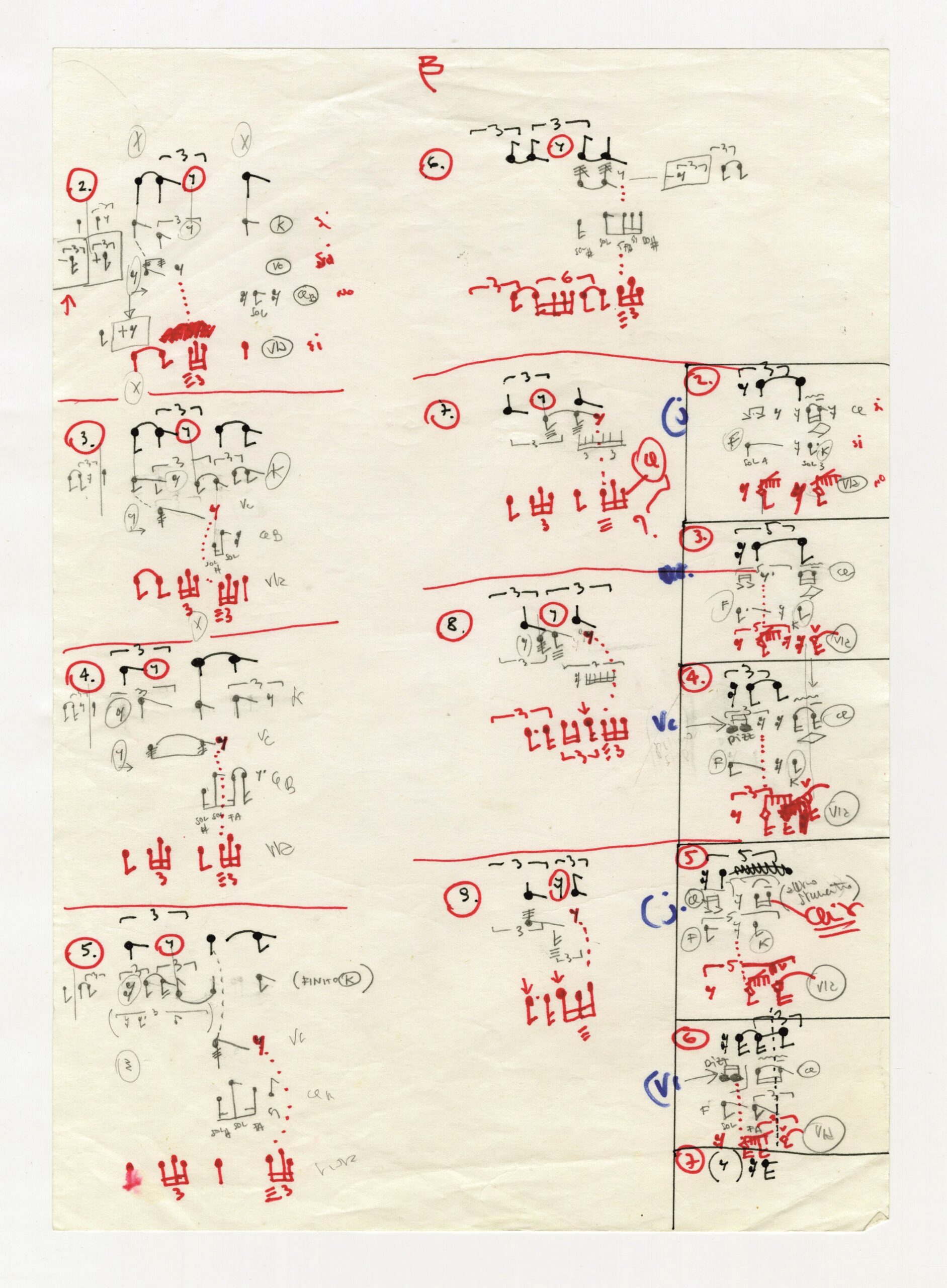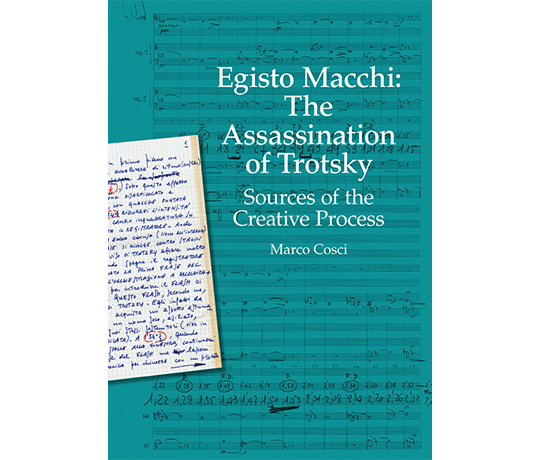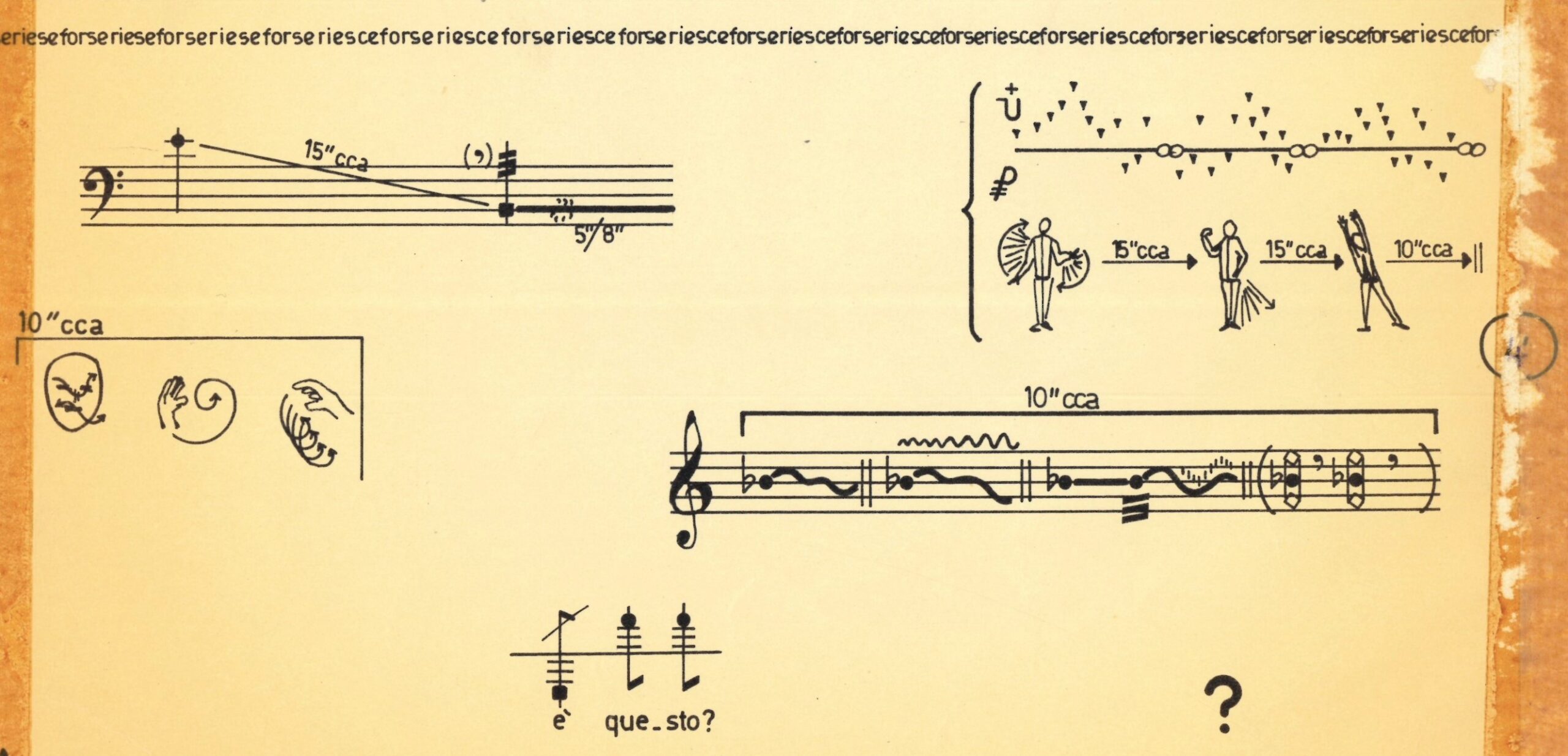Dimensions of Current Compositional Practice: Composers in Dialog with Musicologists
16-18 Luglio 2024
Fondazione Giorgio Cini, Venezia
Scadenza per la presentazione delle domande: 30.4. 2024
Uno degli elementi caratterizzanti della cultura musicale del XX secolo è la riflessione teorica dei compositori – un’attività che si può dispiegare nell’insegnamento, in conferenze, trasmissioni radiofoniche e televisive, in articoli per giornali e riviste, nella pubblicazione di libri e trattati. Tale riflessione rivela l’orizzonte di quesiti a partire dal quale i compositori hanno ideato e realizzato le proprie opere, ma rimanda anche al contesto generale della teoria musicale e a quello ancora più generale della filosofia.
Questo seminario prende spunto dalle Leçons de musique che Pierre Boulez tenne al Collège de France negli anni 1976-1995; il compositore affrontò i nodi fondamentali della tecnica compositiva del XX secolo, presentando non solo la propria visione del processo storico ma fornendo una serie di preziose sollecitazioni all’esegesi musicologica. Da questo modello ricaviamo innanzitutto l’approccio storico, l’indagine dei problemi compositivi a partire dalla loro origine e dalle svariate risposte che hanno avuto nel corso dei decenni. Diversamente dall’impostazione ex cathedra dalle lezioni di Boulez, adottiamo un approccio dialogico a diversi livelli. I concetti di forma, strumento, suono e timbro saranno discussi in alternanza da due compositori che sono da decenni al centro dell’interesse internazionale per le loro opere, l’insegnamento e la loro attività pubblicistica: Agostino Di Scipio e Marco Stroppa. Essi instaureranno a loro volta un dialogo con due musicologi che in didattica e pubblicazioni hanno dato un contributo rilevante alla comprensione della musica del XX e XXI secolo: Mark Delaere e Ulrich Mosch. La funzione di coordinazione delle diverse fasi spetta al direttore dell’Istituto per la Musica: Gianmario Borio.
La lingua del seminario è l’inglese.
Nel quadro della manifestazione si terrà un concerto del mdi ensemble con opere dei due compositori.
I destinatari del bando sono n. 12 compositori e/o musicologi con borsa e n. 12 compositori e/o musicologi senza borsa con marcati interessi teorici e musicologi impegnati in ricerche sulla musica del XX e XXI secolo. Particolare attenzione sarà riservata a candidati nella fase iniziale della carriera (diploma di composizione, dottorato in musicologia ecc.). La commissione terrà altresì conto della composizione internazionale del seminario e del maggior equilibrio possibile tra i generi.