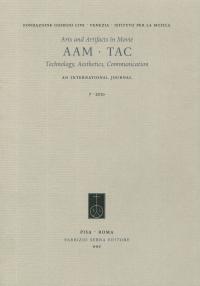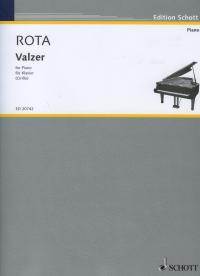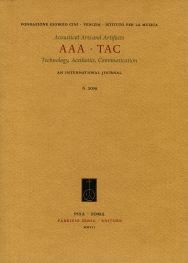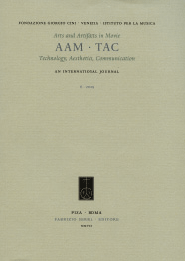Fra ottobre e dicembre continua e si conclude la rassegna video-musicale a Palazzo Cini a San Vio. I due brevi cicli prendono il nome dai tasti forward e stop delle macchine di riproduzione e cercheranno di rendere una forte impressione della pluralità delle passioni, dell’avanzamento e della fermata, nella ricerca artistica contemporanea, ben rappresentata dalla ï¬gura del faggio virgiliano (sub tegmine fagi): una incontrollabile manifestazione d’ipertroï¬a degli organi di senso della bellezza.
Venezia, Palazzo Cini a San Vio
31 Ottobre 2009, ore 17.00
Quinta sessione: Veli di Orfeo. Omaggio a PIERRE HENRY
Le Voile d’Orphée 1953, prova del concerto 2003 16’
Le Voile d’Orphée 1953, concerto 2003 Paris Cité de la Musique 17
Le candidat, film di Gerard Belkin, 1966, con le musiche di Pierre Henry 22’
L’art des sons, film di Eric Darmon & Frank Mallet 2007, ritratto filmato di Pierre Henry 52’
Cooptato sin dai giorni degli inizi della musica concreta da Pierre Scaheffer al Gruppo di Ricerche Musicali Concrete della Radio Francese, il compositore, percussionista, pianista Henry ha sempre dotato del genere musica concreta di ambizioni poetiche che forse il movimento agli esordi non possedeva o controllava.
Ha prodotto sotto l’insegna della musica concreta una massa imponente di creazioni che hanno coinvolto pubblici diversi di diverse generazioni. Se le sue 18 collaborazioni con Maurice Béjart gli hanno offerto una certa notorietà, condimeno Henry ha praticato la creatività condivisa con altri artisti ad ogni livello (pittori, scultori, registi), per non dimenticare le collaborazioni postume con Beethoven, Hugo, l’evangelista Giovanni ecc. Oltre ad avvicinare temi d’abnorme potenzialità semantica, Henry ha lavorato sulle sonorità reali con furia tassonomica (catalogando un numero esorbitante di eventi sonori significativi).
Questa peculiarità della sua ricerca ha portato alla identificazione di uno ‘stile’ nettamente distinguibile, personale, fondato sulla ricchezza degli ascolti, ascolti d’ampiezza cosmica che fanno confluire l’arcaico nel moderno quotidiano, il mitico nel familiare.
Nel 2002 la Philips ha dedicato una ponderosa antologia in 19 CD delle sue opere acustiche del periodo 1949-1999 intitolata Mix Significative sono le partecipazioni di Henry alle creazioni di film, con colonne sonore elaboratissime, di Allegret, Jean Rouch, Henry Decoin, François Weyergans, Mario Ruspoli, Gerard Belkin, Georges Luca, Constantin Costa-Gavras, Ken Russell, Guy Job, Marcel Carné, ecc.