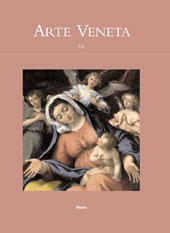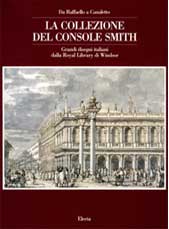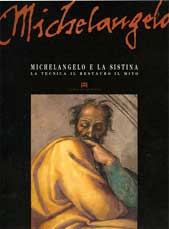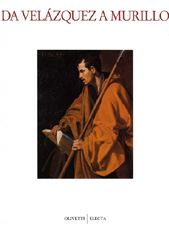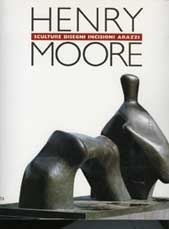Sommario
Arte Veneta: sessant’anni 1947-2007
Anne Markham Schulz, Precisazioni su Giambattista e Lorenzo Bregno
Irina Artemieva, La “Madonna delle Grazie” di Lorenzo Lotto
Renzo Fontana, Lorenzo Lotto in casa D’Armano
Alexander V. Kruglov, “Statua marmorea di Venere nuda, che non fu mai pubblicata”.
Sculture classiche nell’Ermitage provenienti da Venezia
Paola Rossi, Jacopo Tintoretto: disegni respinti, precisazioni attributive
Giuseppe Pavanello, Domenico Manera, cugino di Canova, scultore
Segnalazioni
Chiara Guerzi, Per la pittura veneziana della fine del Duecento: un’inedita “Depositio Christi”
Albert Chatelet, I viaggi di Antonello da Messina
Maria Signori, L’assetto originario dell’altare fondato da Odorico Pojana in San Lorenzo
a Vicenza
Anchise Tempestini, Bambino in piedi e Bambino “gradiens” nelle Madonne belliniane
Antonio Boscardin, La devozione e i ricordi di otto reduci da Padova
Natacha Pernac, Paolo Veronese: “Cristo e l’adultera” Soranzo
Andreas Priever, Ancora sul “Sant’Ercolano e l’angelo” di Benedetto Caliari
Amalia Pacia, Un dipinto inedito di Nicolas Régnier a Bergamo: una traccia per la prima
attività veneziana
Ilaria Mariani, Per il catalogo di Giacomo Contiero e Antonio Gai: novità e precisazioni
Andrea Tomezzoli, Tasselli per la grafica veronese del Settecento
Lionello Puppi, Per Giambattista Pittoni: un dipinto ritrovato
Carte d’archivio
Jan-Christoph Rößler, Precisazioni su palazzo Barbarigo a San Polo e la sua collezione di quadri
Daniele D’Anza, Il certificato di stato libero di Giulio Carpioni
Piero Del Negro, Il governo veneziano e le istituzioni dei pittori tra Sei e Settecento:
da una politica fiscale a una politica culturale
Laura De Fuccia, Per un profilo di “Cochin de Venise”
Nadir Stringa, Un inventario della manifattura Vezzi del 1724
Letture
Catherine Whistler, Lettere artistiche del Settecento veneziano. Il carteggio Giovanni
Maria Sasso – Abraham Hume
Cronache
Sergio Marinelli, Rosso Tintoretto: la mostra del Prado
Ricerche
Per un Atlante della statuaria veneta da giardino: III
a cura di Monica De Vincenti, Simone Guerriero
Bibliografia dell’arte veneta: 2006
a cura di Daniele D’Anza
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it