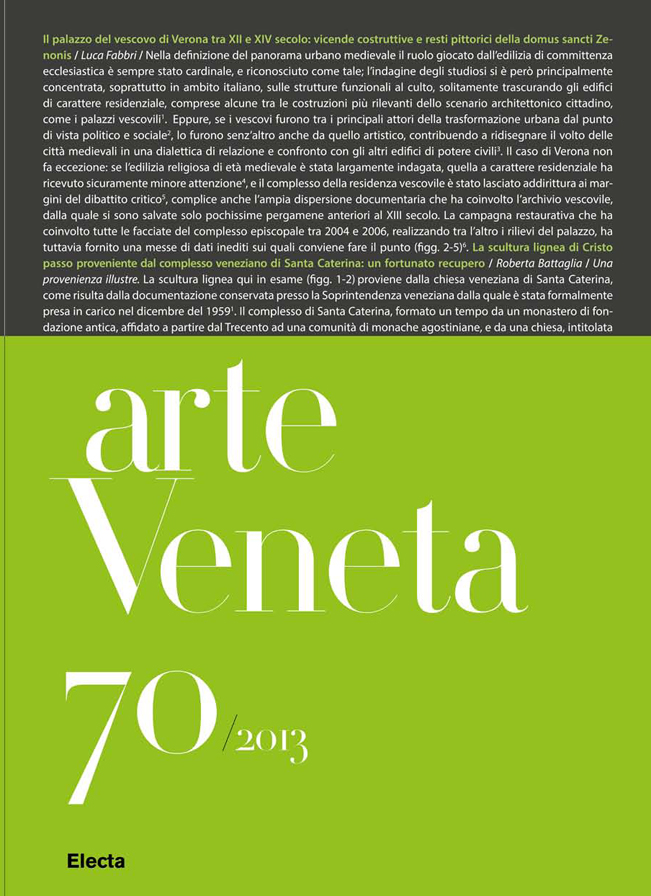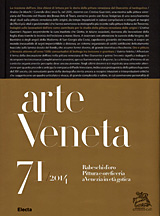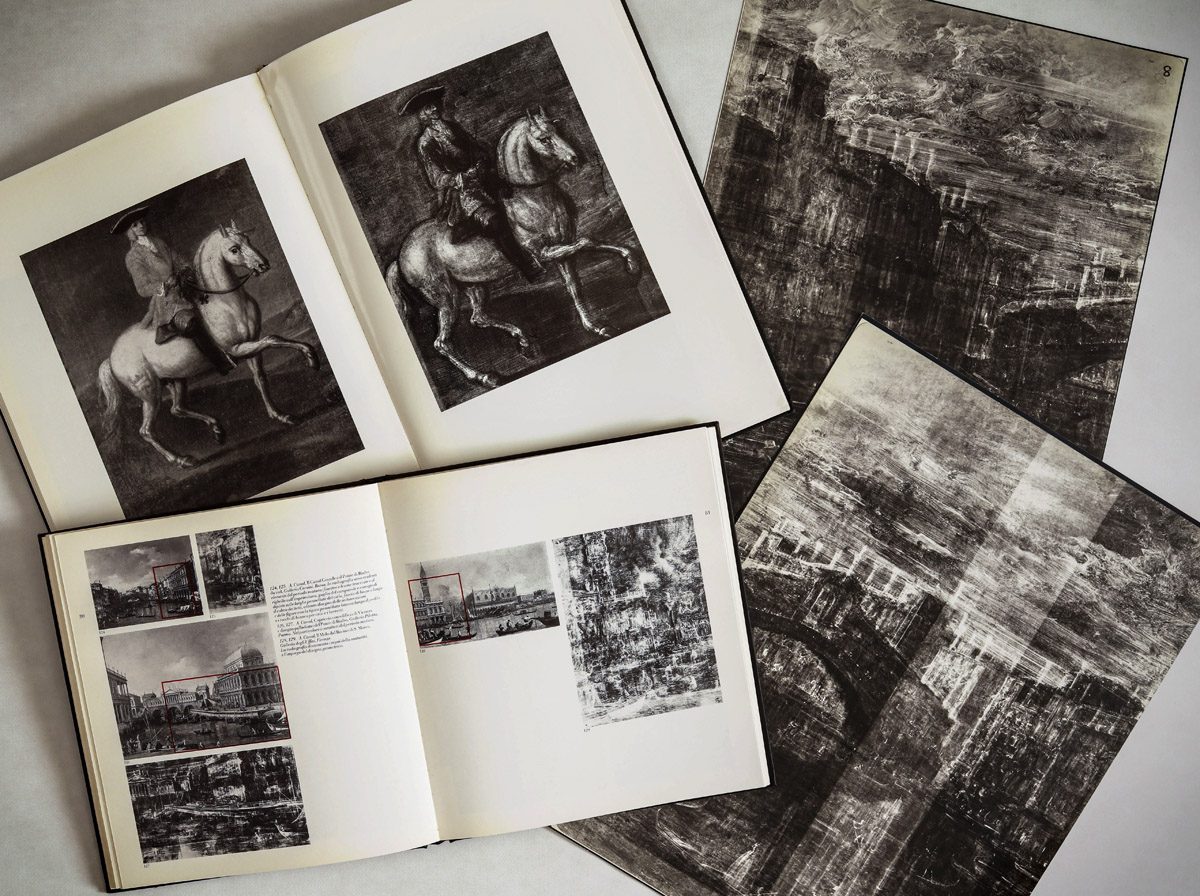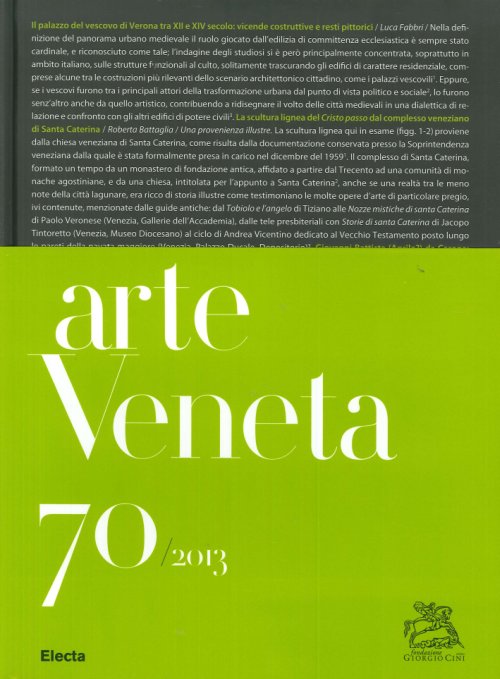Sandro Botticelli e bottega, “Giudizio di Paride”
Palazzo Cini.La Galleria
L’8 Aprile riapre al pubblico, grazie alla partnership di Assicurazioni Generali, la Galleria di Palazzo Cini, elegante residenza sul Canal Grande, con la sua preziosa raccolta di opere d’arte appartenuta a Vittorio Cini. In questo contesto museale raffinato e intimo, oltre all’importante esposizione al secondo piano sui Capolavori ritrovati della collezione di Vittorio Cini, proseguirà l’iniziativa de L’ospite a Palazzo, avviata con grande successo nel 2014, frutto della collaborazione tra la Fondazione Giorgio Cini e le più prestigiose istituzioni museali italiane e internazionali.
La collezione permanente della Galleria sarà arricchita, a partire dal giorno dell’apertura e fino al 6 giugno 2016, da un prestito straordinario: la tela di Andrea Mantegna (Isola di Carturo, 1431ca-Mantova 1506) raffigurante L’evangelista Marco, generosamente concessa dallo Städel Museum di Francoforte sul Meno. Il dipinto realizzato con tempera su tela, è stato ricondotto alla primissima attività padovana del giovane Mantegna, in sintonia con quanto egli andava realizzando nella cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani di Padova tra il 1448 e il 1449, in collaborazione con Nicolò Pizolo: raggiungimento di insuperata qualità della fase giovanile del pittore e caposaldo della pittura di matrice antiquaria nell’Italia padana del Quattrocento. La lezione del Maestro Squarcione, leggibile nella resa dei dettagli, si incontra con la più piena adesione alla concezione di una solida prospettiva, costante dell’arte mantegnesca, che colloca il santo, assorto nella speculazione divina, nell’aggetto dell’edicola marmorea, di classica compostezza. Un illusionismo spaziale di aulica e trattenuta gravità – ulteriormente ribadito dal cartiglio ancorato al parapetto che reca la firma e l’invocazione al patrimonio marciano – che fa del dipinto di Francoforte uno dei punti fermi della giovinezza di uno dei più geniali pittori del Rinascimento.