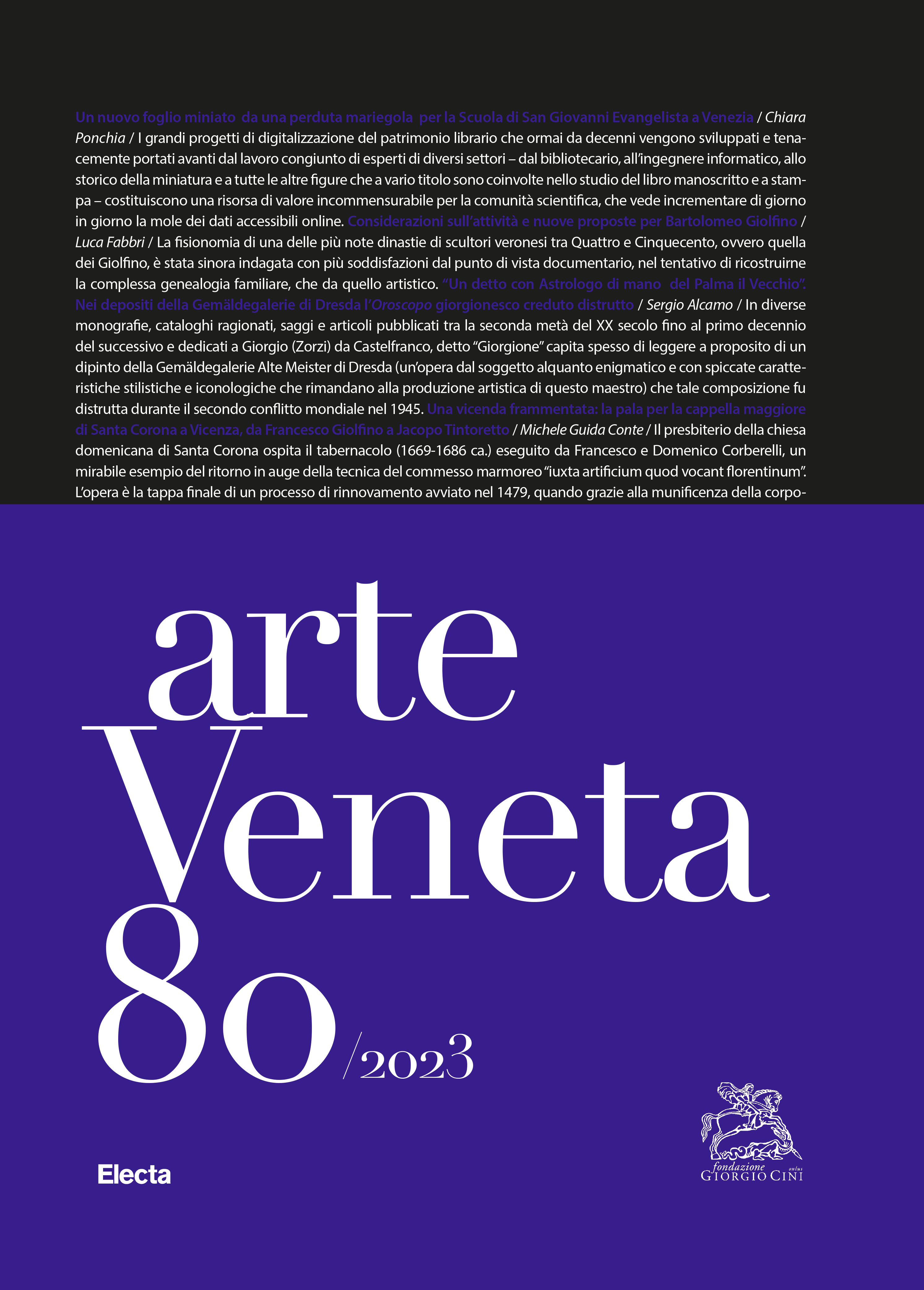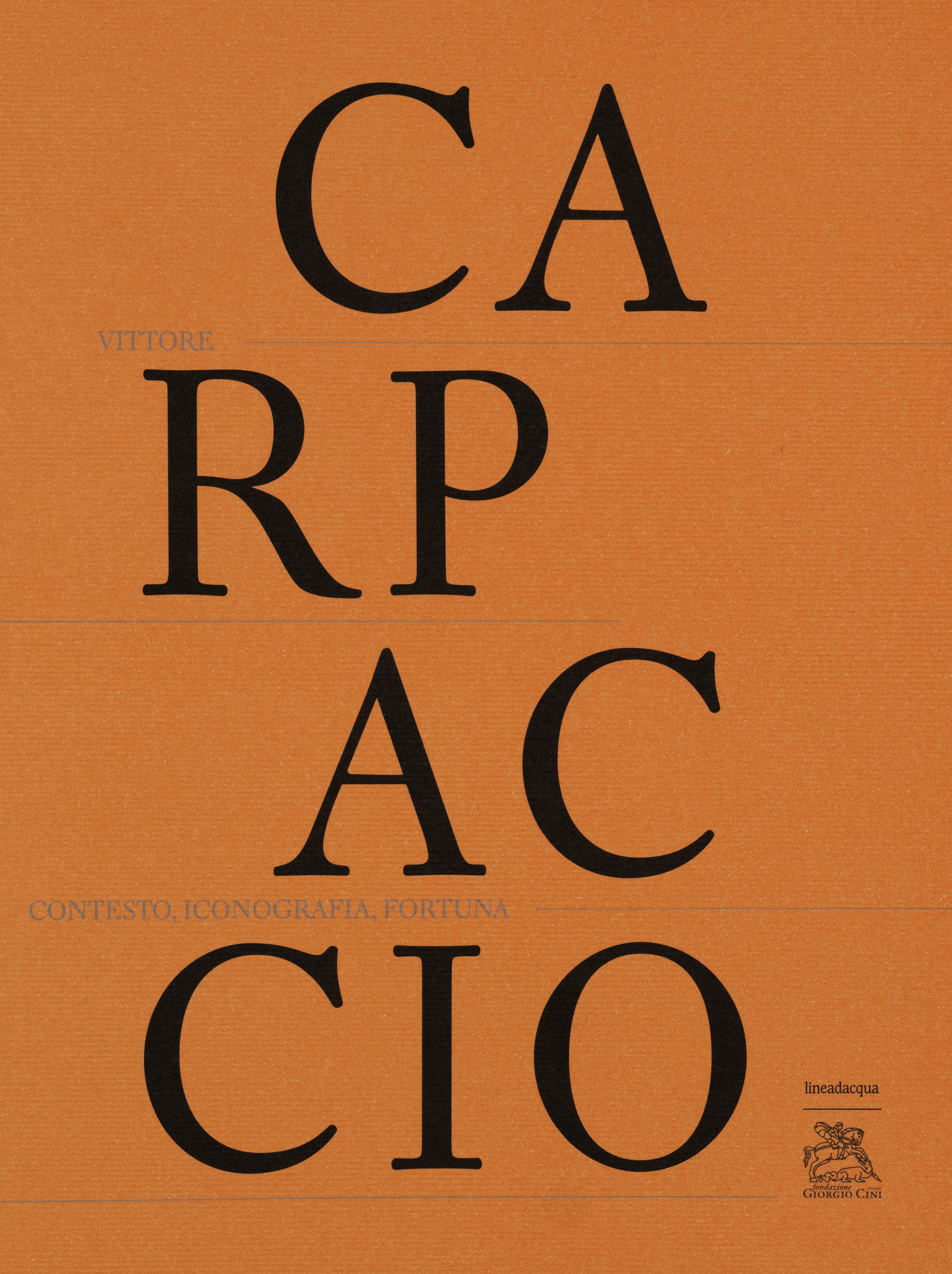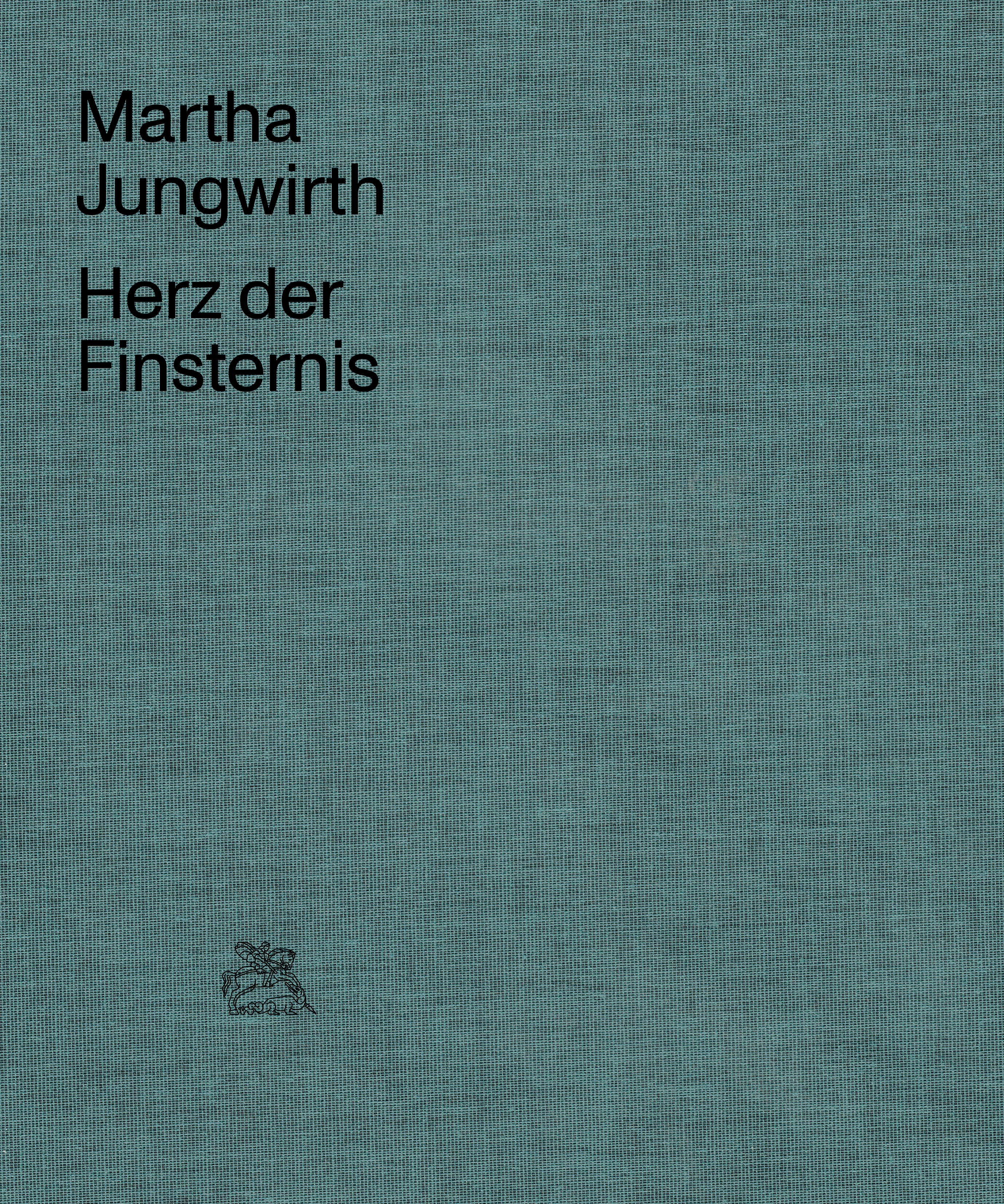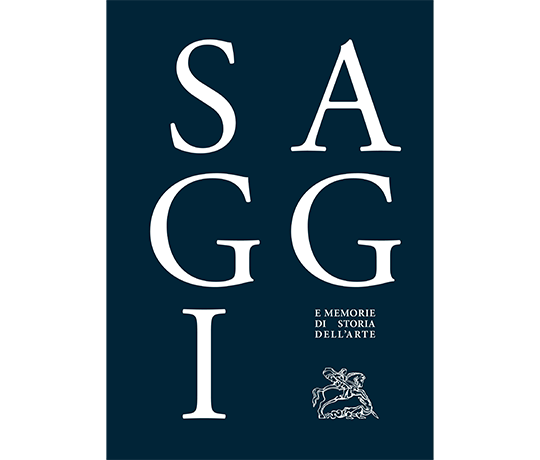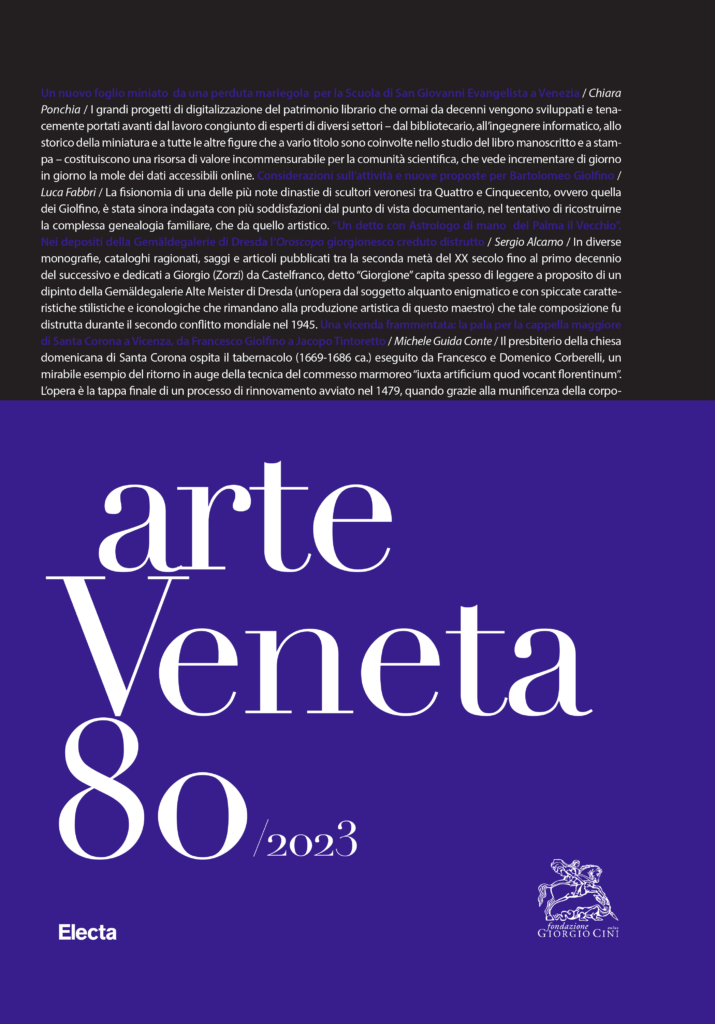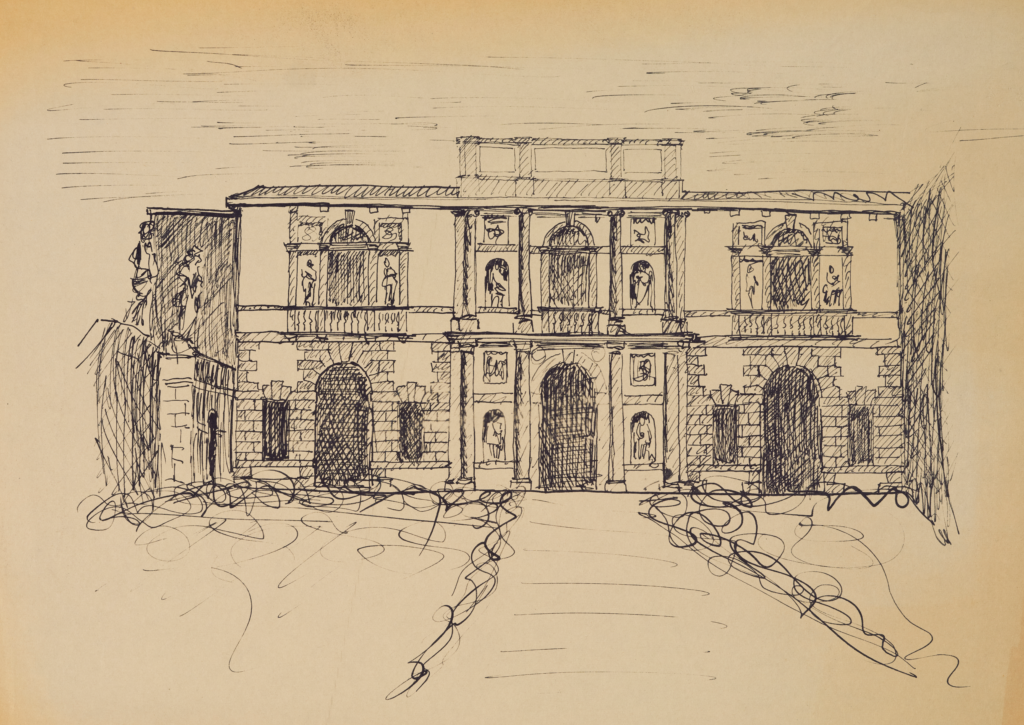Ritornano le Conversazioni d’Arte a Palazzo Cini.
Nella rassegna di questa stagione, storici dell’arte ed esperti guideranno il pubblico alla scoperta dei tesori d’arte della collezione di Vittorio Cini. Capolavori medievali e rinascimentali saranno raccontati e illustrati, approfondendo le tematiche e le peculiarità che ogni opera racchiude.Uno speciale incontro è riservato a “L’ospite a Palazzo”: Il Cristo crocifisso di Antoon Van Dyck, straordinario prestito del Palazzo Reale di Genova.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa prenotazione tramite mail: palazzocini@cini.it.
30 aprile | h 17:00
Tesori d’arte nella collezione dei fondi oro di Vittorio Cini
Cristina Guarnieri
Università degli Studi di Padova
14 maggio | h 17:00
L’ospite a Palazzo. Il Cristo Crocifisso di Antoon van Dyck del Palazzo Reale di Genova
Mari Pietrogiovanna
Università degli Studi di Padova
28 maggio | h 17:00
L’Officina ferrarese sul Canal Grande. Tesori estensi della Collezione Cini
Roberto Cara, Valentina Lapierre
Storici dell’arte, Ferrara
5 giugno | h 17:00
Le ‘forme simboliche’ nei capolavori rinascimentali del palazzo di San Vio
Loredana Luisa Pavanello
Fondazione Giorgio Cini, Venezia