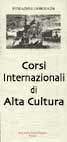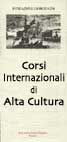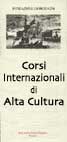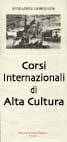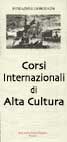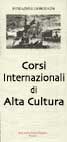Continuando e sviluppando la trattazione del tema «Concetto, storia, miti e immagini del Medioevo» iniziata nel settembre del 1972, il XV Corso Internazionale d’Alta Cultura affronterà lo studio degli aspetti e dei problemi della civiltà fra i secoli XIII e XV.
Naturalmente come nel corso precedente ebbero rilievo speciale i problemi e le vicende politiche religiose filosofiche, così in questo richiederanno più estesa e impegnata presentazione le espressioni artistiche, letterarie e culturali perché tipiche e rivelatrici in quell’età di grandi rinnovamenti spirituali e civili.
Attenzione particolare sarà riservata anche alla periodizzazione e alla immagine che di questa età crearono le successive e differenti culture. Lezioni e seminari integrativi saranno annunciati negli appositi calendari.
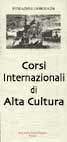
Continuando l’esame degli aspetti e dei problemi della civiltà contemporanea, iniziato col XVI Corso «Dal Romanticismo al Surrealismo», il XVII Corso studierà le tendenze e i fermenti che nel nostro secolo ancora in qualche modo si ispirano o reagiscono al movimento romantico, in un clima generale di metamorfosi della ragione.
È abbastanza evidente che sul piano artistico-letterario, accanto, dopo o contro il surrealismo, hanno trovato ampio e dialettico sviluppo altri movimenti, analoghi o divergenti, come il futurismo e l’esistenzialismo, il cubismo e l’astrattismo, lo strutturalismo e il formalismo, il neo-dadaismo e l’iperrealismo; e così, sul piano filosofico sociale, il bergsonismo e pragmatismo, il materialismo storico, freudismo, neo-hegelismo e neo-socialismo.
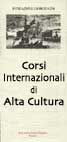
Il XIX Corso internazionale d’alta cultura della Fondazione Giorgio Cini tratterà un argomento di particolare attualità: i rapporti fra l’Europa e l’America anglosassone nel XX secolo. Quello degli scambi e degli incontri fra ideologie e modelli culturali, cioè dei rapporti di civiltà fra due mondi così distanti e tuttavia così indissolubilmente connessi, è un terreno fecondo che si presta a essere approfondito nelle più ampie e diverse implicazioni: politiche, sociali, economiche, religiose, artistiche, letterarie, linguistiche, di costume e di concezione.
La scelta dei docenti di Università italiane, americane, francesi e inglesi e di alcuni scrittori particolarmente significativi, che sono stati invitati a tenere le lezioni e i seminari rispecchia, appunto, questa varietà e questa ampiezza di prospettive che, ovviamente, consentiranno di saggiare il tema generale, cogliendone problemi e aspetti vari.Sono previsti documentazioni e incontri su artisti americani a Venezia.

Proprio mentre la potenza della Serenissima si andava spegnendo, le sue arti e la sua cultura entravano in una circolazione decisiva nella civiltà d’Italia e d’Europa. Dopo essere stata nel primo Settecento la predella del rilancio della cultura italiana più nuova – a cominciare da quella vichiana – Venezia, nella seconda metà del secolo, colle sue esperienze socio-politiche e colla diaspora dei suoi ingegni trasfonde linfe vitali nel mondo civile, dall’estremo Nord coi suoi Bellotto e Quarenghi e dall’Inghilterra col Canaletto alla Francia col Goldoni e alla Spagna col Tiepolo, e fino all’America col Da Ponte. E nello stesso tempo accoglie lezioni ed esempi dalle varie culture europee che filtra e trasmette alla nuova realtà italiana. La Direzione del Corso si riserva eventuali modifiche al presente programma.
Di esse sarà data volta per volta tempestiva notizia.
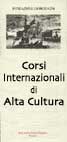
Il XXII Corso Internazionale d’Alta Cultura, dopo quattro anni dedicati a trattazioni storico-artistiche, ritornerà a presentare e a dibattere un argomento attuale nella nostra cultura e a carattere dichiaratamente problematico. Nella ricerca dei valori secondo cui si ordina un sistema culturale, le varie discipline umanistiche – dalla storia alla critica letteraria e artistica – trovano un punto d’incontro nell’interpretazione delle opere d’arte quali forme portatrici di significato e quali combinazioni specifiche di elementi formali e tematici, le cui funzioni mutano nel tempo in rapporto a nuovi contesti culturali. Tanto le opere letterarie quanto quelle figurative vanno perciò percepite, lette, indagate e comprese attraverso quella che Panofsky chiamò «storia delle tradizioni». Il codice iconologico diviene il centro di un processo semantico comune all’arte e alla letteratura.Tre momenti esemplari saranno particolarmente studiati nelle tre settimane: quello tardo rinascimentale e barocco, quello illuministico e neoclassico, quello romantico e decadentista. Poiché il Corso avrà carattere seminariale, alle lezioni seguiranno discussioni e seminari sui vari argomenti. Di essi sarà data tempestiva notizia. La Direzione del Corso si riserva eventuali modifiche ai presente programma.

Il Corso studierà quest’anno la situazione dell’Europa riformista e la vigilia della rivoluzione francese dal punto di vista politico e socioeconomico, filosofico e religioso, artistico e letterario, con particolare riguardo all’Italia e a Venezia. A distanza di due secoli, una rivisitazione critica di questo periodo, «sull’orlo della crisi», consentirà di studiare aspetti e problemi noti e di riscoprirne meno noti, che mostreranno come il processo rinnovatore fosse, in gran parte, non solo iniziato ma molto avanzato anche prima che la rivoluzione francese vi ponesse il più vistoso sigillo della storia. Poiché il Corso avrà carattere seminariale, alle lezioni seguiranno sedute di seminario e discussioni sui vari argomenti, delle quali sarà data tempestiva notizia. La Direzione del Corso si riserva eventuali modifiche al presente programma e la precisazione di qualche titolo.
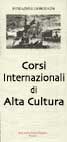
Nel quadro delle attività promosse in Italia nell’Anno Europeo della Musica, la Fondazione Giorgio Cini dedicherà il suo XXVII Corso internazionale d’alta cultura al tema «La musica nella formazione e nello sviluppo della civiltà europea». Tale corso – che avrà carattere non solo culturale e musicologico ma anche musicale – comprenderà una serie di lezioni, seminari, esercitazioni, esecuzioni e concerti riguardanti i vari momenti della musica in Europa, dal Medio Evo a oggi, nelle implicazioni culturali più diverse e nelle connessioni con la letteratura, il pensiero filosofico, le arti figurative, la vita sociale, la committenza. Durante e subito dopo il Corso si terranno due convegni internazionali di studio: «Il Teatro musicale a Venezia e a Napoli nel Settecento» (9-1 1 settembre) e «Andrea Gabrieli nella civiltà veneziana del Cinquecento» (16-18 settembre), che integreranno il programma del Corso stesso. Poiché il Corso avrà carattere seminariale e dimostrativo, alle lezioni seguiranno discussioni e seminari sui vari argomenti, e si affiancheranno concerti. Di essi sarà data tempestiva notizia. La Direzione del Corso si riserva inoltre eventuali modifiche al presente programma e la precisazione di qualche titolo.Volume L’Europa musicale. Un nuovo rinascimento: la civiltà dell’ascolto