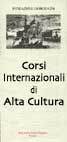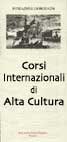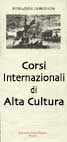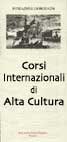
Nel XVI Corso Internazionale di Alta Cultura sarà esaminata e studiata un’epoca che è di fondamentale interesse ideologico, culturale e sociale per la vita contemporanea: cioè il Romanticismo negli aspetti e nei problemi, nelle manifestazioni e negli sviluppi che attraverso i vari romanticismi – da quello più propriamente storico alle varie forme di contestazioni irrazionali – si sono susseguiti fino ad oggi. Come nei precedenti Corsi dedicati al Medio Evo e al Rinascimento, lo studio sul movimento romantico sarà condotto – con impostazione di carattere europeo e interdisciplinare – attraverso l’indagine degli aspetti storici, artistici, filosofici, politici, ideologici atti a porne in luce le idee-forza e la complessa fenomenologia. Le tendenze e gli aspetti del teatro romantico saranno trattati nel Corso particolare di cui è unito il programma: altre lezioni e seminari integrativi saranno annunciati negli appositi calendari settimanali.
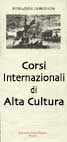
Volume Tiziano e il Manierismo europeo

In conformità all’impostazione e al metodo dei Corsi sul Barocco e sull’Umanesimo che ebbero, nel settembre del 1959 e 1960, singolare successo, questo III Corso d’Alta Cultura a carattere internazionale si propone di illustrare il Rinascimento a Venezia in confronto e in relazione con quello d’altri luoghi d’Italia e d’altri Paesi europei, con particolare riguardo alle arti figurative e ai rapporti fra pensiero, cultura, lettere, musica, arti minori.
Le grandi Mostre storiche «Carlo Crivelli e i Crivelleschi» e «Il Mantegna e i Mantegneschi», organizzate rispettivamente a Venezia e a Mantova, e il Convegno Internazionale «Arte, pensiero e cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la Toscana e con il Veneto», il quale avrà quali giornate veneziane il 29 e 30 settembre, offriranno eccezionali possibilità di approfondire genesi e sviluppi del Rinascimento culturale e figurativo veneziano.
Le lezioni e le esercitazioni si svolgeranno dal 9 settembre al 1 ottobre a Venezia, all’Isola di San Giorgio Maggiore, sede della Fondazione Giorgio Cini, e negli ambienti artistici più adatti all’argomento studiato (gallerie, chiese, palazzi, ecc.), e saranno integrate da riunioni di seminario.

La scelta di un tale tema di studio ha concorso, in una certa misura, a illuminare l’opera del pittore Vittore Carpaccio, di cui era stata allestita una mostra al Palazzo Ducale, sotto la direzione di Pietro Zampetti, nel quadro delle Mostre biennali d’antica arte veneta.
Il problema dell’«Oriente» nei grandi pittori del Quattrocento veneziano è un problema tuttora vivo e discusso: che esso sia un’Oriente reale o poeticamente rievocato importa fino a un certo punto.
Ciò che più importa, a nostro modo di vedere, è il fatto che questa visione orientalizzante si sia verificata a Venezia e abbia permeato di sé la pittura veneziana del Quattrocento, a tal punto da costituire una delle sue caratteristiche fondamentali; ed è naturale che sia avvenuto così, perché in Venezia esistevano i presupposti più lontani di questo «orientalismo», offerto anche dalle sue chiese e dai suoi palazzi; perché nei veneziani ci fu sempre un’aderenza intellettuale, e oserei dire affettiva, a forme di importazione orientale e precipuamente bizantine che andava al di là della pura e semplice importazione delle idee, considerando tali forme come parti integranti di un costume di vita, di una tradizione liberamente accettata.

Riprendendo il programma di carattere storico, interrotto l’anno scorso con uno di impostazione metodologica sulla civiltà contemporanea, il VII Corso Internazionale d’Alta Cultura si propone di studiare alcuni aspetti e problemi della cultura e dell’arte nel Settecento: e più precisamente il rapporto fra sensibilità e razionalità, fra pre-romanticismo e illuminismo, fra arcadia e neoclassicismo, nella luce ideale dei rapporti fra Venezia e l’Europa.
La grande Mostra dei Guardi, organizzata dal Comune di Venezia, offrirà alla ricca problematica del tema una eccezionale occasione di aperture e di approfondimenti. Di particolare interesse per i partecipanti sarà anche la mostra «I disegni veneti al Museo di Budapest», che l’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini allestirà da giugno a settembre.
Sono previste illustrazioni e esercitazioni alla Mostra dei Guardi, visite ai monumenti cittadini più rappresentativi di questo periodo, gite di istruzione nei dintorni e nella laguna. Le lezioni si svolgeranno all’isola di San Giorgio Maggiore, sede della Fondazione Giorgio Cini, tutti i giorni, secondo il programma di massima che segue: le esercitazioni, i seminari, le visite ai monumenti cittadini e alle gallerie pubbliche e private avranno luogo nella mattinata, e verranno annunciate di volta in volta.

Questo nono Corso riprende l’impostazione storica di altri precedenti e si propone di studiare il problema, centrale alla civiltà del Settecento, del rapporto tra rappresentazione artistica e rappresentazione scientifica.
La ricerca di un nuovo linguaggio nella direzione scientifica imposta dalla cultura galileiana e post-galileiana si afferma, nel Settecento, come il problema essenziale dell’espressione tanto per la scienza quanto per la letteratura e per le arti. Interpretazioni tutte scientifiche della pittura (fino alle teorizzazioni del Berkeley), profonde preoccupazioni sul rapporto tra parola, segno e immagine (fino alle prese di posizione del Lessing, di Du Bos e di Burke), estremi tentativi di una poesia che partendo dal didascalico puntava risolutamente allo scientifico, discussioni di carattere squisitamente tecnico sui mondi e sui modi delle arti figurative: ecco alcuni aspetti del tema proposto, che verranno studiati durante lo svolgimento del Corso.
La grande mostra storica «Vedutisti veneziani nel Settecento», in Palazzo Ducale, organizzata dal Comune di Venezia, offrirà un’occasione di studio su quel particolare momento pittorico e, insieme, un’eccezionale possibilità di aperture e di approfondimenti per la ricca problematica del tema.
Sono previste illustrazioni e esercitazioni alla mostra dei «Vedutisti veneziani nel Settecento», visite di studio ai monumenti cittadini settecenteschi più rappresentativi, gite di istruzione nei dintorni della città e nella laguna.

L’XI Corso Internazionale d’Alta Cultura si propone quest’anno di esaminare il sorgere e lo svolgersi della critica come elemento essenziale e caratteristico della vita moderna, dal secondo Settecento ad oggi.
Nella nostra civiltà, le stesse forme creative tradizionali assumono spesso veste e valore critico: dal romanzo-saggio alle espressioni artistiche di impostazione critica. Anzi, la società contemporanea pare caratterizzata, per la prima volta nella storia, dalla sincronia della produzione e della verifica critica della produzione stessa.
Le celebrazioni del Centenario di Cavalcaselle e la grande Mostra storica dei pittori veneziani ‘di figura’ del Settecento «Dal Ricci al Tiepolo», organizzata dalla Direzione delle Belle Arti del Comune di Venezia a Palazzo Ducale, da giugno a ottobre, offriranno occasione di aperture e di approfondimenti per la ricca problematica del tema.

Nella trattazione del Corso si vorrebbe allargare il concetto di ecologia dalla semplice considerazione dei fatti naturali e di ordine materiale, a una indagine degli elementi umani e spirituali che influenzano e spesso determinano l’ambiente stesso. Prevalentemente, l’ecologia è indirizzata a una difesa dell’ambiente naturale come spazio vitale dell’uomo; più raramente invece l’ambiente è considerato quale naturale proiezione e prolungamento dell’attività dell’uomo, in un conveniente adattamento o adeguamento degli elementi fisici a quelli spirituali.
L’ambiente, o gli ambienti, devono essere considerati in funzione della vita materiale e spirituale dell’uomo, devono aiutarlo, favorirlo, potenziarlo nelle sue espressioni e attività: non devono essere considerati per se stessi come elementi immutabili; e lo stesso progresso tecnico deve essere programmato per la sopravvivenza, anzi per lo sviluppo dell’uomo.
Di qui l’interesse a studiare quelli che sono stati e sono i reciproci adattamenti, non passivi ma attivi, dell’uomo e dell’ambiente, sino a considerare l’azione che certe grandi personalità o certi gruppi umani hanno esercitato coscientemente e intelligentemente sulla natura.
Un esempio tipico è Venezia: sarà illustrato in lezioni e sopralluoghi e anche nella Mostra delle opere restaurate e recuperate preparata dal Comune di Venezia.