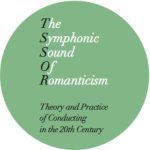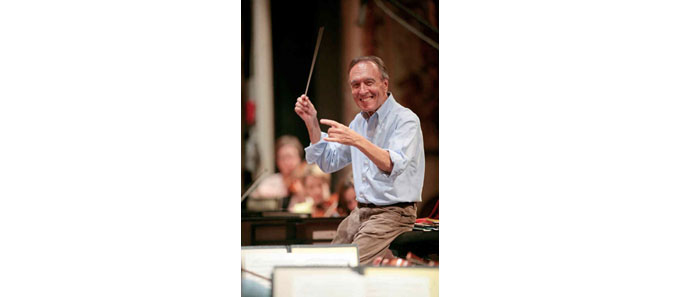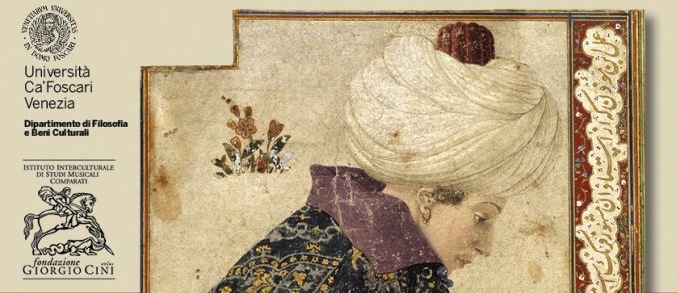L’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati organizza un corso di formazione della durata di due giorni rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Il corso, a cura di Serena Facci e Gabriella Santini, si propone di analizzare i video musicali al fine di guidare gli studenti ad una fruizione consapevole di questo mezzo così diffuso, elaborare percorsi didattici di tipo interculturale e interdisciplinare, sollecitare attività creative che utilizzino il linguaggio multimediale dei video. La lettura critica di questo genere di produzioni multimediali aiuta a comprendere la funzione comunicativa dei diversi linguaggi che concorrono alla loro realizzazione. Le competenze acquisite possono inoltre essere investite, in sede scolastica, per guidare gli studenti nella produzione di video.
Agli insegnanti partecipanti verranno forniti supporti didattici sotto forma di testi scritti e materiale video. I percorsi scelti mireranno a coinvolgere docenti di diverse discipline, oltre musica, anche lettere, arte e immagine, lingua straniera, tecnologia. In particolare, il corso di formazione sarà articolato in due parti.
Nella prima parte, gli insegnanti analizzeranno alcuni video musicali proposti dalle docenti del corso, utilizzando una metodologia basata sulle funzioni dei diversi linguaggi. Si lavorerà con video musicali italiani e stranieri caratterizzati da contenuti musicali e ambientali di diversa provenienza geografica.
Nella seconda parte, l’attività del laboratorio didattico sarà dedicata più specificamente a suggerimenti e sperimentazioni per la produzione in classe di video musicali, che utilizzino le grandi potenzialità di Internet per connettere l’immensa varietà di spazi, suoni, immagini, linguaggi e suggestioni.
Il corso è riconosciuto dall’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto.
Il corso è a numero chiuso, i partecipanti sono ammessi fino ad esaurimento posti.
Iscrizione obbligatoria entro il 11 ottobre 2014, si prega di scaricare il modulo d’iscrizione e inviarlo a: musica.comparata@cini.it