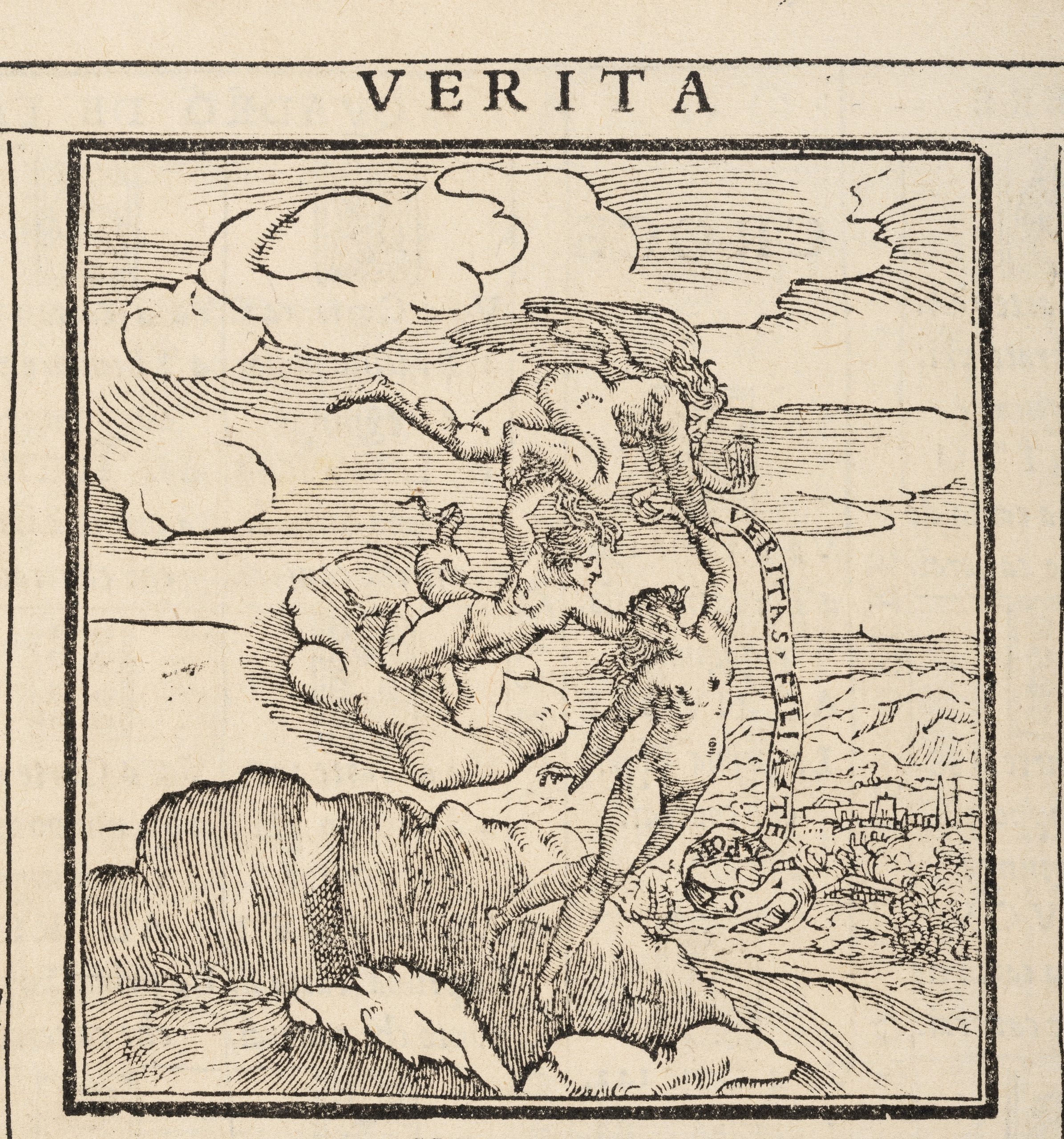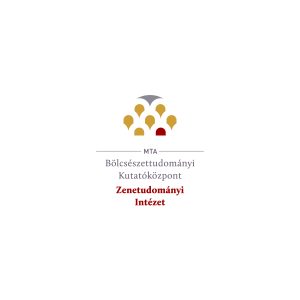Seminario Musiche (e musicologie) del XXI secolo
Gli etnomusicologi, che da sempre si occupano di musiche ‘viventi’, devono misurarsi con la continua ridefinizione dei luoghi e delle pratiche della produzione musicale. In questa prospettiva, lo studio di registrazione è diventato negli ultimi decenni un importante luogo di ricerca. Il tema sul quale si intende riflettere è la possibile applicazione dell’indagine etnografica, propria del metodo antropologico, a un mondo contemporaneo e tecnologico quale quello degli studi di registrazione, con l’obiettivo di costruire modelli interpretativi sulle musiche contemporanee. Alcune questioni ‘classiche’ della ricerca etnomusicologica (studio dei processi creativi, performativi, status del musicista) si possono affiancare a nuove questioni sollevate dal mutato contesto – lo studio di registrazione – nel quale si svolgono (mancanza di pubblico diretto, rapporto con le tecnologie sempre più sofisticate, delocalizzazione e frammentazione del lavoro di gruppo, ruolo creativo di figure professionali diverse dal musicista, quali il produttore, il fonico).
Nel corso del XX secolo, l’evoluzione dei luoghi di produzione di musiche riprodotte ha accompagnato sia i musicisti nell’adattare il loro fare musica, sia gli studiosi nell’elaborare strategie di comprensione dei fenomeni musicali. Lo studio di registrazione è stato il territorio principale in cui è avvenuto il passaggio tra il mondo dell’oralità/scrittura a quello dell’oralità meccanica ed è diventato inoltre un luogo privilegiato per la miscela di generi, stili, strumenti musicali, ma anche di ricerca. Gli studiosi che interverranno al Seminario hanno formazione e biografie (musicali e scientifiche) molto diverse tra loro: studiosi di etnomusicologia, di popular music, produttori musicali, musicisti con esperienze di ricerca in contesti nelle diverse parti del globo e nell’ambito dei più diversi generi musicali (musiche di tradizione orale, popular music, jazz, musica contemporanea, musica per il cinema). Assieme rifletteranno su come l’idea di “etnografia”, proveniente dagli studi etno-antropologici, applicata ad un contesto come lo studio di registrazione – il luogo dove, forse più che nei concerti, i musicisti oggi si incontrano – stia fornendo strumenti innovativi di comprensione dei modi in cui la musica viene oggi prevalentemente concepita, eseguita e prodotta, e su come una prospettiva antropologica sia necessaria allo studio dei processi musicali contemporanei nei quali la tecnologia è sempre più pervasiva e raffinata e la diffusione mediatica sempre più determinante in ogni angolo del globo.
Giovedì Mattina, 24 gennaio
9.30-10.00
Serena Facci and Giovanni Giuriati
Introductory remarks
10.00-11.00
Alessandro Bratus
Processi che risolvono problemi. Lo studio di registrazione nelle culture della popular music, dalla nicchia alla norma – e ritorno
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00
Thomas Turino
Recording as Replica/Recording as Musical Practice
Giovedì Pomeriggio, 24 gennaio
14.30-16.00
Jeremy Wayne Wallach
The Entextualization of Performative Sociality: Ethnomusicological Approaches to Sonic Encoding and Decoding
16.00-16.30 Coffee break
16.30-18.00
Ilario Meandri
Memorie orali e archeologia della tecnica: International Recording (1959-1969)
Venerdì mattina, 25 gennaio
9.30-11.00
Marco Lutzu
Approcci etnografici alla fonofissazione. Alcune riflessioni sulla produzione discografica in Sardegna
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00
Hans Weisethaunet
The Ethnography of Recording—Sound, Agency, and Objects
Venerdì pomeriggio, 25 gennaio
14.30-17.30
Francesco Giannattasio, Pasquale Minieri, Simone Tarsitani
Esperienze e nuove sfide della produzione musicale in studio
Sabato Mattina, 26 gennaio
9.30-10.00
Alessandro Cosentino
Chitarristi dal Botswana e dal Malawi: creatività individuali in studio di registrazione
10.00-10.30
Vera Vecchiarelli
“La rifaceva anche centinaia di volte”: sulla registrazione della voce di De André in studio.
10.30-11.00 Coffee break
11.00-12.30
Eliot Bates
Technological and methodological assemblages: Analyzing the production of culture in Istanbul’s recording studios
12.30-13.30
Final discussion