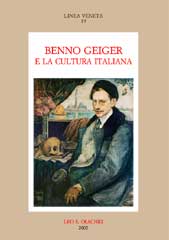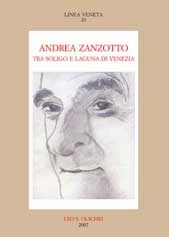Malipiero-Malipiero
/ Malipiero-Maderna / Maderna-Maderna: nonostante la evidente
tripartizione schematica, questo non è un libro «proporzionato»,
raccoglie infatti saggi e interventi di studio di diverso formato e in
nessuna delle tre ‘sezioni’ che lo compongono paò dirsi organico,
esaustivo. Prevale innanzitutto l’ultimo Malipiero (che è anche il
Malipiero meno noto, il Malipiero desuetissimo) ovvero prevale un
Malipiero tangenziale al suo stesso esercizio primario di
«compositore-creatore» senza vincoli di mestiere.
Si scrive poi, per contro, ad equilibrare lo sbilancio, solo del
primissimo Maderna, il Maderna degli esordi, mettendo a fuoco aspetti
di molte questioni ancora molto aperte.
Al centro di quest’assetto monografico gli studiosi si sono dedicati
alle «relazioni» interpersonali, inter-poetiche, sviluppando il tema
che dà titolo a tutta la raccolta; ma senza ordine o ordini prescritti
e previsti. Eppure nonostante la gracilità dell’impianto apertissimo,
sia gli argomenti che i metodi di approfondimento filologico, usati per
indagarli, trasferiscono in questo libro dati di novità non
trascurabili.
Del resto è anche vero che questo è un libro d’occasione, generato da
un accumulo di indagini diverse sollecitate dalla ricorrenza del
ventennale della scomparsa dei due autori veneziani, entrambi, maestro
e allievo, vecchio e giovane scomparsi, pressoché assieme, nel 1973
(1973-1993). Indagini stimolate dal fatto che uno, il giovane, ha
parlato più volte ma sempre in modo piuttosto leggendario dell’altro
come di un suo maestro, un maestro atipico, ma importante.
Mi è doverosa un’ultima considerazione e un ricordo: il gruppo degli
studiosi che partecipano a questa miscellanea è generazionalmente
eterogeneo; è un fatto che aspira ad essere un pregio: il segnale di un
incontro e di uno scambio di esperienze e di continuità nell’evoluzione
delle conoscenze di chi ama e studia questi autori. Basti pensare che
Mario Messinis, nel 1971, fu l’editor dell’ultima raccolta, per altro
anch’essa congeriale, di studi malipieriani prodotti in simultanea a
Malipiero ancora in vita. Tra gli altri, a partecipare a questo
incontro c’è, nell’indice del libro, anche lo scomparso John
Waterhouse: si pubblica infatti in questo volume l’ultimo dei suoi
saggi, ultimo frutto del ventennale lavoro di indagini sull’opera di
Malipiero: un saggio ancora inedito. Per tutti noi la sua assidua
partecipazione a tutte le discussioni sulla musica italiana del
Novecento, in tutte le sedi, e la sua opera di promozione e
valorizzazione dei musicisti italiani tutti, non sono soltanto dei
commossi ricordi, sono degli esempi sempre attuali e tuttora viventi.
INDICE
Premessa del curatore
Introduzioni
1. Mario Messinis, Malipiero, vent’anni dopo (1973-1993)
2. Marzio Pieri, Parlata per una gita al faro Malipiero
Parte I
GIAN FRANCESCO MALIPIERO
Paolo Cattelan, Il «Sogno» dannunziano, ovvero «come sbarazzarsene». Ariele, Bonaventura a il teatro di Malipiero
Tilman Schlömp, La canzone d’opera e l’opera come canzone. Struttura e funzione di una forma nel teatro del primo Malipiero
Emilio Sala, Malipiero al Teatro Greco di Siracusa. Le musiche di scena per l’«Ecuba» di Euripide (1939) e l’«Orestea» di Eschilo (1948)
John C. G. Waterhouse, Gian Francesco Malipiero e la decafonia
Laura Zanella, Otto auto-imprestiti per un’opera nuova. Gian Francesco Malipiero e l’epilogo drammatico degli «Eroi di Bonaventura» (1968)
PARTE II
MALIPIERO E MADERNA
Francesca Magnani, Il canto nell’immaginario teatrale di Malipiero e Maderna
Rossana Dal Monte, Tracce di Malipiero e Maderna nei registri e negli schedari della Marciana
Annibale Cetrangolo, Malipiero al Teatro Greco di Siracusa. Le musiche di scena per l’«Ecuba» di Euripide (1939) e l’«Orestea» di Eschilo (1948)
Joachim Noller, «Quando gli strumenti cantano». Malipiero, Maderna, la metafisica e il concetto d’espressione nel Novecento
Paolo Pinamonti, Maderna dirige Malipiero
Parte III
MADERNA OLTRE MALIPIERO
Mario Baroni, Sull’opportunità di una ri-edizione delle opere di Bruno Maderna. Qualche Considerazione di metodo critico
Susanna Pasticci, Maderna verso il pensiero seriale. La «Fantasia e fuga per due pianoforti (1949)»
Paolo Cattelan, Biografia di un concerto di Maderna: il «Concerto per due pianoforti e strumenti»
Stefano Bellon, Il «Concerto per due pianoforti e strumenti» di Bruno Maderna verso Darmstadt: un’analisi della partitura
Indice dei nomi
Per informazioni
e-mail: ufficio.editoriale@cini.it